menu start: Tue May 20 06:38:48 CEST 2025
menu end: Tue May 20 06:38:48 CEST 2025
menu start: Tue May 20 06:38:48 CEST 2025
menu end: Tue May 20 06:38:48 CEST 2025

Emergono nuovi elementi d’incertezza, mentre restano irrisolti quelli già esistenti. L’economia globale ed europea si trovano ad affrontare una combinazione di rischi noti a cui si sommano nuove incertezze. Da un lato, i fattori geopolitici continuano a pesare, mentre dall’altro, l’attesa per l’insediamento della nuova amministrazione USA, il rischio di un rallentamento dell’economia cinese e le dinamiche politiche in Francia e Germania acuiscono le fragilità del quadro di riferimento. Il livello di incertezza nell’ultimo decennio è strutturalmente più elevato rispetto a quello precedente. Dopo il picco del 2020 legato alla pandemia da Coronavirus, il grado di incertezza era temporaneamente calato, per tornare a risalire già due anni dopo con lo scoppio della guerra in Ucraina. Più di recente l’incertezza ha subito un nuovo rialzo, seppure più contenuto, legato al dubbio sull’esito delle elezioni negli USA (Grafico A). Seppure ormai l’esito delle elezioni che ha portato alla seconda Presidenza di Donald Trump è chiaro, l’incertezza è attesa protrarsi almeno fino al suo insediamento a gennaio e ai primi provvedimenti che adotterà la nuova amministrazione.

Gli shock e gli altri elementi d’incertezza ostacolano le imprese attraverso vari canali. Il panorama internazionale rende da tempo impossibile operare in un clima di “business as usual”. Le tensioni USA-Cina hanno già prodotto risultati in termini di maggiore distacco delle filiere europee oltre che statunitensi da quelle cinesi. Se nell’immediato l’impatto è stato limitato per l’Italia data l’esposizione relativamente bassa delle sue imprese esportatrici sul mercato cinese, effetti indiretti sono inevitabili a causa del freno che il decoupling comporta per l’economia tedesca, già ferita dai rincari energetici a seguito dell’invasione russa dell’Ucraina. L’indebolimento dei fondamentali economici è aggravato dalle fragilità politiche che si stanno manifestando oltre che in Germania, anche in Francia. In Germania il Cancelliere Scholz ha già perso malamente la fiducia del Bundestag e il Paese si avvia verso elezioni anticipate nel 2025. Anche la Francia potrebbe dover ricorrere a elezioni anticipate nel 2025 per far fronte all’instabilità del Governo in carica. Essendo l’UE il primo mercato di sbocco per l’export italiano (anche di macchinari), ciò potrebbe tradursi in un generale indebolimento della componente estera dei consumi.
A rendere ancor più complesso lo scenario è l’instabilità geopolitica del Medio Oriente, che ha avuto dirette conseguenze sul trasporto merci, allungando tempi di percorrenza e aumentando i costi delle tratte marittime.
Insieme agli effetti dei numerosi shock sopra elencati vanno considerati quelli prodotti dalle tendenze di lungo periodo, come la digitalizzazione e i cambiamenti climatici. Le imprese, infatti, si trovano a dover innovare di continuo sia per tenere il passo con il progresso tecnologico, sia per l’adozione di strategie di produzione sempre più sostenibili. Ne emerge un quadro di riferimento caratterizzato da un grado di complessità straordinario (Grafico B).

L’economia globale rimane resiliente, nonostante l’eterogeneità tra paesi e settori. Si prevede che la crescita del PIL globale si rafforzerà leggermente al 3,3% nel 2025 e rimarrà stabile a questo livello fino al 2026. L’inflazione continua a moderarsi e la componente “core” rientra ormai negli obiettivi delle banche centrali per la maggior parte delle economie. Anche la tensione sul mercato del lavoro si è allentata, seppure i tassi di disoccupazione rimangano generalmente pari o prossimi ai minimi storici. Tuttavia, i rischi gettano un’ombra su quello che altrimenti sarebbe uno scenario centrale relativamente positivo. I principali rischi riguardano l’intensificarsi ulteriore delle tensioni geopolitiche, l’inflazione che potrebbe rivelarsi più persistente del previsto e una brusca rivalutazione del rischio nei mercati finanziari.
Automazione, creatività e tecnologia (ACT) dei macchinari italiani come leva di competitività. Nell’affrontare lo scenario internazionale, l’Italia può contare sulle esportazioni a elevata sofisticazione di beni strumentali. In particolare, su quelli che si distinguono per l’alta intensità di automazione, creatività e tecnologia. ACT comprende 225 categorie di prodotto che si articolano in 12 comparti legati alla produzione di macchinari e accomunate soprattutto dall’elevato grado di precisione, da una presenza dell’elettronica sempre più pervasiva rispetto alla parte meccanica, dall’agilità nell’adottare soluzioni su misura e da un crescente contenuto di servizi nell’offerta di vendita (Grafico C). Per la quasi totalità delle categorie di beni considerate (212 su 225), l’Italia esprime un vantaggio competitivo sia in termini di prezzo applicato per la vendita, sia, a parità
di prezzo, per le più elevate quantità di macchinari vendute.
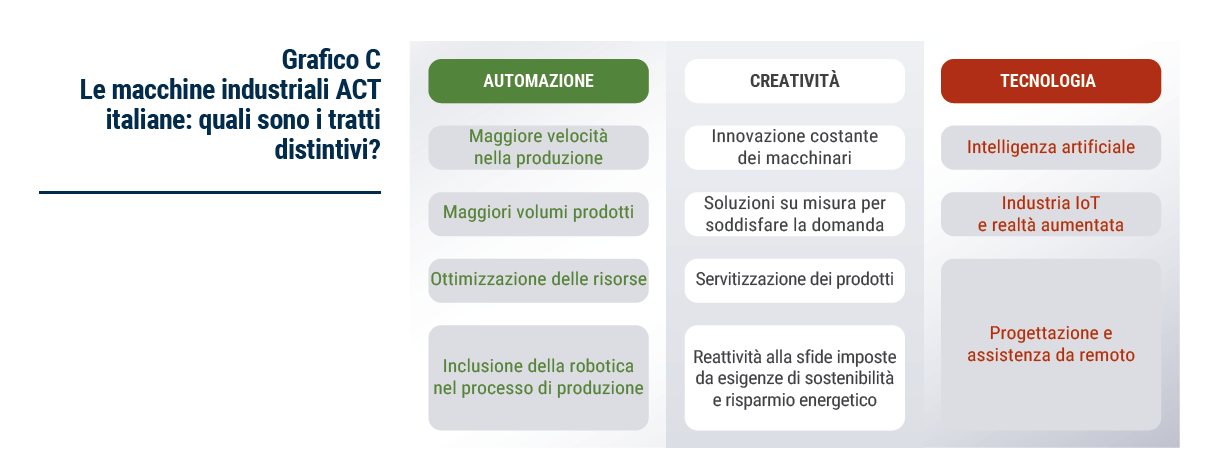
Le esportazioni di beni ACT frenano nella prima metà del 2024, rispetto alla buona performance del 2023. Nonostante l’elevato grado di incertezza, nel 2023 le aziende italiane del settore dei macchinari industriali ACT hanno registrato una crescita annuale a prezzi correnti del 7% rispetto al 2022, anno che a sua volta aveva segnato un forte rialzo (+9,4%). I primi sette mesi del 2024 si è assistito a una brusca frenata che ha portato a una contrazione del -1,7% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
I risultati preliminari dei primi sette mesi dell’anno indicano che il 2024 rappresenta un anno di stallo per l’export dei macchinari, soprattutto per l’importante componente che si rivolge al mercato europeo. Le esportazioni di macchinari dirette verso il Nord America e il Medio Oriente hanno continuato a crescere, con incrementi rispettivamente del +2,7% e del +10,5% rispetto all’anno precedente. Al contrario, l’Asia orientale e l’Europa mostrano segnali di rallentamento, con cali rispettivamente del -6,3% e del -2,5%. Questi risultati non solo riflettono le dinamiche della domanda regionale, ma anche l’impatto delle politiche industriali e commerciali adottate dai paesi concorrenti, che, nel caso asiatico, risentono inevitabilmente del disaccoppiamento con le filiere occidentali.
La crescente competizione nei settori tecnologici e industriali a livello globale rende centrale per le imprese italiane riorientare le loro strategie commerciali, puntando a consolidare la presenza nei mercati più dinamici e a diversificare le aree di esportazione per ridurre i rischi legati alla concentrazione geografica. Tra i settori più dinamici si distinguono le macchine per confezionamento e imballaggio (con un incremento rispettivamente del 18,9% nel 2023 e del 6,8% tendenziale nei primi sette mesi del 2024) e le macchine utensili, robot e automazione (+23,6% nel 2023 e +13% nei primi sette mesi del 2024).
L’Italia è tra i primi paesi per quota di mercato delle esportazioni di macchinari ACT. Nel 2022 l’Italia si è posizionata quarta, dietro Cina, Germania e Giappone. Nel quadriennio 2018-2022 la quota dell’Italia si è leggermente ridotta (8,2% nel 2022 dall’8,8% nel 2018) ed è comunque quella che ha tenuto meglio l'espansione del peso cinese (18,1% da 13,5%) rispetto alla Germania (17,8% da 19,6%) e al Giappone (9,3% da 10,6%).
Stati Uniti e Germania da soli assorbono poco meno di un quarto dei macchinari italiani. I principali importatori di macchinari ACT sono rappresentati da Stati Uniti (12%), Germania (10,3%), Cina (6,4%), Francia (6%) e Spagna (4%). Questi cinque paesi assorbono più di un terzo delle esportazioni italiane di macchinari ACT, con una quota complessiva del 38,6%. Se si considerano i primi dieci mercati di destinazione, la quota sale al 54,5%, indicando una concentrazione significativa delle esportazioni italiane verso un numero relativamente ristretto di paesi, con un forte orientamento verso i principali mercati avanzati.
Nonostante ciò, l’Italia si posiziona terza per numero di mercati raggiunti, presidiandone il 50,6% di quelli possibili (in tutto 42.510) rispetto al 72,8% della Cina e al 53,5% della Germania.
L’export ACT vale 32,1 miliardi di euro. Il valore delle esportazioni di macchinari italiani ACT nel mondo può essere diviso per mercati di destinazione. Quelli ad avere maggior peso nell’export delle eccellenze italiane ACT sono i mercati avanzati, che ne assorbono più di 21,6 miliardi di euro. Il valore delle esportazioni nei mercati emergenti è invece più limitato e registra 10,5 miliardi di euro. L’export di ACT è cresciuto in particolar modo nelle Americhe, tanto nel Nord quanto in America Latina e nei Caraibi, destinazioni che hanno registrato la crescita maggiore nel corso degli ultimi anni. Il Grafico D offre una panoramica della distribuzione geografica per quote percentuali delle esportazioni italiane di macchinari ACT nel mondo.
…e circa 8 miliardi di potenziale aggiuntivo. Nonostante le prospettive della domanda mondiale siano in rallentamento, con le economie europee a registrarne quello più marcato, rimangono significative le possibilità di ampliare l’export di prodotti ACT. Il potenziale sfruttabile sembrerebbe distribuito piuttosto equamente tra paesi avanzati ed emergenti (circa 4,6 miliardi di euro per i primi e 3,3 nei secondi), suggerendo quindi alle imprese di accrescere le loro quote di mercato in entrambi.



Mercati avanzati ed emergenti pongono sfide diverse ma offrono entrambi un elevato potenziale sfruttabile. Per quanto riguarda i mercati avanzati, la notevole dimensione del mercato USA pesa molto sulla determinazione del potenziale per l’export italiano ACT: il mercato statunitense da solo conta per 760 milioni di export potenziale aggiuntivo. Seguono la Germania e la Francia con circa 470 milioni ciascuno. Il settore dei Sistemi e componenti meccatronici per la trasmissione di potenza è il più promettente in tutti questi mercati, mentre i concorrenti più frequenti sono la Cina e la Germania. Tra i principali paesi emergenti primeggia la Cina con un potenziale aggiuntivo di circa 760 milioni di euro, seguita dall’India con 472 milioni e dalla Turchia con 364 milioni. Oltre ai Sistemi e componenti meccatronici per la trasmissione di potenza, negli emergenti è elevata la componente delle Macchine per l’industria tessile, i cui principali concorrenti dell’Italia restano Cina e Germania. Per maggiori dettagli su destinazioni geografiche più ricorrenti, principali comparti e relativi concorrenti si veda la Tabella A.
Il potenziale sfruttabile negli emergenti è accompagnato da un maggiore rischio di credito. Tensioni geopolitiche e conflitti hanno contribuito a un deterioramento marcato del rischio in vari paesi. A risentire maggiormente di questi fattori sono stati i paesi emergenti, sia per le loro economie più esposte, sia per la presenza di livelli di rischio più elevati già in partenza, per le maggiori fragilità nei fondamentali economici e per sistemi regolamentari più distanti dagli standard occidentali. In molti casi, già a partire dalla crisi pandemica, si è assistito a un indebitamento pubblico e privato più elevato, che porta con sé un deterioramento generalizzato nel rischio di credito. Per comprenderne le implicazioni, l’analisi del potenziale si accompagna a quella del rischio che ciascun mercato presenta (Grafico E). Non sorprende il posizionamento così elevato di Russia e Iran nella scala di rischio di credito, trattandosi di due paesi coinvolti, seppure a titolo diverso, in scenari di conflitto. Rimangono relativamente sicuri i paesi avanzati, che peraltro rappresentano la destinazione più rilevante per le esportazioni di ACT. Non può infine essere trascurata la Cina, il paese con il maggiore potenziale di export tra gli emergenti. Attualmente il rischio di credito non è elevato, ma un marcato rallentamento dell’economia o i delicati scenari internazionali in corso potrebbero peggiorarne il profilo.
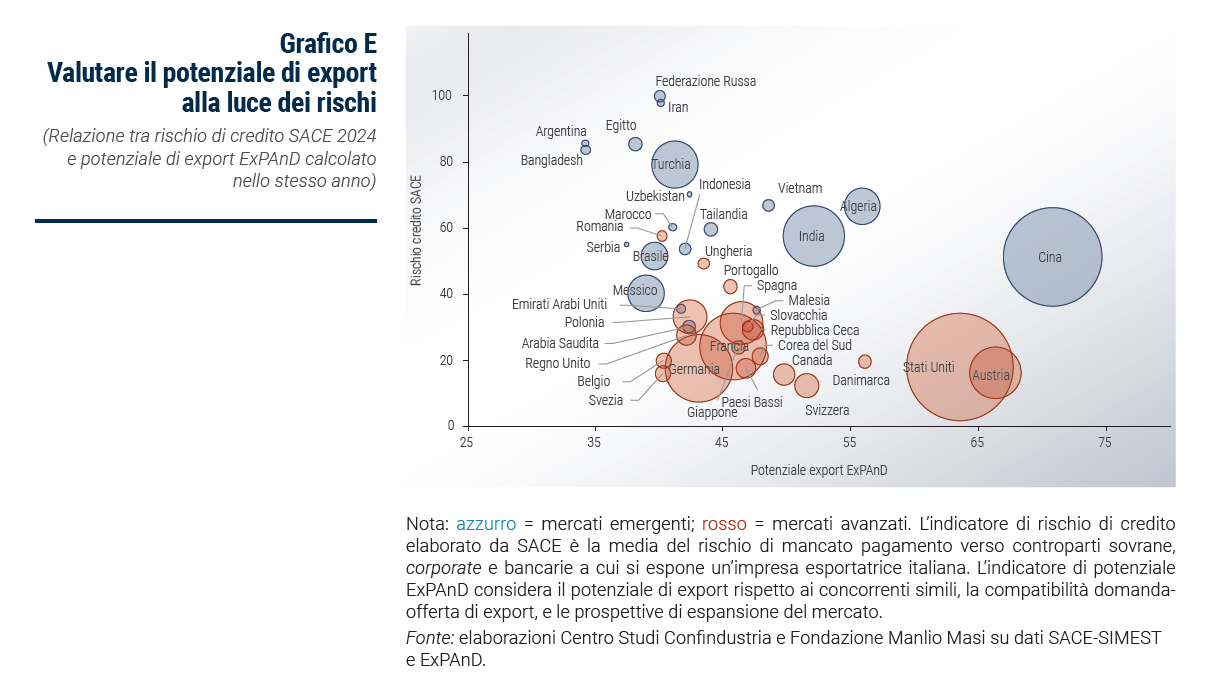
I nuovi equilibri internazionali riportano al centro l’America Latina nelle filiere internazionali. L’area dell’America Latina e Caraibi (ALC) negli ultimi anni sembra aver intrapreso una strada virtuosa di crescita e sviluppo. Secondo le stime della Banca Mondiale, nel 2024 il tasso di crescita del PIL dell’area ALC è atteso intorno al +1,9%, e la previsione per il 2025 è di un +2,6%. La crescita registrata finora e quella prevista per il futuro restano tuttavia inferiori rispetto alle previsioni per le altre principali aree geografiche. Le prospettive di sviluppo potrebbero essere ulteriormente rafforzate dalle tendenze di nearshoring o friendshoring in atto negli USA. Tali politiche potrebbero infatti rappresentare un’opportunità per i paesi dell’ALC di attrarre attività produttive sul proprio territorio alla luce del vantaggio competitivo dovuto alla vicinanza geografica con gli Stati Uniti. In questo quadro, risulta fondamentale per l’Italia caratterizzarsi come un partner commerciale forte e credibile nella regione, e in parte sembra già aver intrapreso la giusta strada. Il peso dell’area ALC sul totale dell’export complessivo italiano si è attestato nel 2023 al 3,1%, per un valore di intorno ai 19,3 miliardi di euro, registrando un tasso di crescita medio annuo (CAGR) del 3,6% dal 2014. I principali partner commerciali risultano essere il Messico con una quota nel 2023 del 32,9% e il Brasile con una quota del 28,2%. Seguono, a notevole distanza, l’Argentina (7,2%) e il Cile (6,8%).
Il Messico primo per domanda di beni ACT nell’area. Circa il 90% dell’export mondiale di beni ACT nell’area latino-caraibica è catturato da sei economie: Messico, Brasile, Argentina, Cile, Colombia e Perù. Tra queste, il Messico si posiziona al primo posto come principale mercato di sbocco per i beni ACT nell’area ALC (45,1%). L’economia centro-americana risulta il principale importatore di macchinari dell’area anche a livello mondiale. Il Messico è peraltro l’economia più aperta tra le principali dell’area: l’interscambio commerciale rappresenta infatti l’88% del PIL. La principale leva è sicuramente la vicinanza con il vicino mercato statunitense, ma non è l’unica. La manifattura messicana è particolarmente diversificata, soprattutto se paragonata a quella di molti peer dell’area. Pur essendo formalmente ancora etichettato come emergente, il Paese è di fatto un’economia avanzata dal punto di vista della diversificazione produttiva. Peraltro, la forza lavoro operante nel tessuto produttivo locale è ben istruita, qualificata e disponibile a costi relativamente competitivi. Le molteplici politiche attuate dal Governo per promuovere lo sviluppo industriale multisettoriale e attrarre investimenti nei settori ad alta tecnologia hanno creato un ambiente imprenditoriale favorevole, rendendo il Messico un attore globale nella produzione di beni complessi e ad alto valore aggiunto. L’industria automobilistica rimane una pietra miliare della produzione messicana, ma non è più l’unico settore su cui punta il Paese. Negli ultimi anni, in particolare, il Messico è emerso come un hub per la produzione ad alta tecnologia: settori come l’aerospaziale, i dispositivi medici e l’elettronica hanno visto una crescita significativa, contribuendo a espandere la base manifatturiera del Paese e ad attrarre investimenti esteri. Non stupisce quindi che il mercato messicano risulti tra i primi cinque paesi emergenti per potenziale dell’export di beni ACT, con un margine di miglioramento pari a 281 milioni di euro.
L’Italia è già impegnata nel promuovere l’industrializzazione dei Paesi ALC ma ci sono margini per rafforzare la cooperazione. Le imprese italiane sono già coinvolte in progetti volti a rafforzare lo sviluppo tecnologico nell’area. In tal senso, sono sicuramente degni d’attenzione i Centri Tecnologici creati in America Latina, anche grazie al contributo delle Associazioni del Sistema di Confindustria, che costituiscono un vettore d’entrata nei mercati della regione della tecnologia italiana, offrendo formazione per l’uso di quest’ultima e un supporto di qualità allo sviluppo industriale dei paesi ricettori. Esempi di questi sono il CESAT (centro tecnico per l’industria delle materie plastiche e della gomma, ideato principalmente per fornire formazione e assistenza alle numerose imprese locali) nello stato di Puebla e il CIMMATH (centro d’innovazione italiano-messicano per la manifattura ad alta tecnologia) nello stato di Hidalgo, entrambi in Messico. Risultati più significativi in termini di internazionalizzazione delle nostre imprese potrebbero derivare anche da una maggior partecipazione a programmi di cooperazione internazionale, nei quali la partecipazione italiana risulta ancora debole. Tra i bandi di gara indetti dalla banca multilaterale della regione, la Banca Interamericana di Sviluppo (IDB), per esempio, si osserva che a fronte degli oltre 33 miliardi di dollari stanziati negli ultimi 10 anni dall’istituto (per circa 80.000 progetti di vario tipo), le aziende italiane si sono aggiudicate appena 90 gare, per un ammontare di soli 203 milioni di dollari, valori corrispondenti a meno dell’1% del totale, di cui in gran maggioranza facenti capo al settore “consulenza ingegneristica”. Peraltro, osservando la natura dei bandi messi a gara dalla Banca si evince che molti Paesi della regione sono interessati da progetti per la cui realizzazione sarebbe necessaria l’importazione di macchinari e tecnologia italiani. Molti riguardano settori come l’elettro-mobilità, le infrastrutture di trasporto, la creazione di sistemi per lo stoccaggio e la trasmissione energetica, e altri semplicemente il supporto a programmi di rafforzamento industriale.
La realizzazione del potenziale passa per il rafforzamento della capacità produttiva e dipende anche dalle scelte di policy. Il fatto che ci siano ampi margini di miglioramento per l’export italiano di macchinari non significa che la sua realizzazione sia automatica. Aumentare le esportazioni implica a monte un aumento della produzione, che a sua volta passa per una crescita degli investimenti. A tal fine, è necessario uno sforzo coordinato di imprese e istituzioni per favorire un irrobustimento generalizzato del sistema produttivo italiano e della sua competitività lungo vari assi. Se da un lato le imprese dovrebbero impegnarsi nel destinare risorse a investimenti produttivi, dall’altro le istituzioni dovrebbero spronare questo processo attraverso la mitigazione degli elementi di incertezza che condizionano le scelte di investimento e predisporre incentivi per tutte le imprese che decidano di reinvestire i propri utili per l’acquisto di beni strumentali.
La digitalizzazione resta il tallone d’Achille per le imprese italiane ed europee. Come messo in chiara evidenza nel rapporto “Il futuro della competitività europea”, l’Italia e l’Europa devono colmare il gap di competitività con Cina e Stati Uniti. Concentrandosi sul divario di produttività tra imprese europee e statunitensi, emerge chiaramente come questo sia spiegato in gran parte dal settore tecnologico: l’UE è debole nelle tecnologie emergenti che potrebbero rivelarsi chiave per la crescita futura, con solo 4 delle 50 aziende tecnologiche più importanti al mondo. Peraltro, al momento non esiste alcuna azienda nel continente europeo con capitalizzazione di mercato superiore a 100 miliardi di euro creata negli ultimi 50 anni (negli USA le sei aziende con capitalizzazione superiore ai 1.000 miliardi sono state create tutte in questo periodo). Lo scarso dinamismo delle aziende UE si riflette anche in una performance più debole nella spesa in ricerca e innovazione (R&I), inferiore di 270 miliardi di euro rispetto alle loro controparti statunitensi nel 2021. La questione centrale non sembra essere che l’Europa manchi di idee o di ambizione, essendoci molti ricercatori e imprenditori di talento che depositano brevetti. La sfida più grande è quella di tradurre l’innovazione in commercializzazione. Le aziende innovative che vogliono crescere in Europa sono ostacolate in ogni fase da normative incoerenti e restrittive.
L’intelligenza artificiale (IA) sarà centrale in tutti gli ambiti produttivi. Il rafforzamento della digitalizzazione è necessario non solo per restare competitivi nelle nuove tecnologie, ma anche per integrare l’IA nelle industrie esistenti, in modo che possano restare all’avanguardia nei decenni futuri.
Occorre fin da subito sgomberare il campo da equivoci: l’IA è ormai un fattore strutturale del nostro sistema socio-tecnico-economico, essendo in grado di ridurre le disuguaglianze di natura cognitiva in quanto fondata sul linguaggio e quindi contraddistinta da una facilità d’uso senza eguali. Ci si dovrà abituare a considerare l’adozione dell’IA alla stregua dell’introduzione dell’energia elettrica: a rappresentarne, da un lato, l’impatto pervasivo e, dall’altro, il potenziale effetto trasformativo nelle dinamiche di funzionamento di persone, imprese e oggetti. Il mercato dell’intelligenza artificiale, in Italia, cresce in misura consistente anche perché ci si muove su una scala ancora davvero minimale. Nel 2023 ha segnato +52%, raggiungendo il valore di 760 milioni di euro. Occorre tuttavia considerare che l’Europa investe il 5% di quanto fanno gli USA in IA e che l’Italia si trova nelle retrovie europee. Il quadro è dunque in crescita, ma partiamo da una situazione di grave ritardo.
Le PMI fanno più fatica a tenere il passo con l’IA: nel 2023 il 61% delle grandi imprese ha all’attivo, almeno a livello di sperimentazione, un progetto di IA, mentre si scende al 18% tra le piccole e medie imprese. L’adozione nelle imprese è sostanzialmente stabile rispetto al 2022.
In un contesto sempre più incerto è bene rafforzare gli accordi commerciali già esistenti e porre le basi per dei nuovi. Il susseguirsi di eventi che hanno scosso le economie globali, rendendo maggiormente frammentate le catene di produzione, ha evidenziato l’importanza di stringere accordi che garantiscano il corretto svolgimento delle attività anche in condizioni di elevata complessità.
Per l’Italia, questo significa rafforzare i suoi legami commerciali principalmente con i paesi dell’Unione Europea, un importante sbocco per le vendite di macchinari ACT e la principale fonte di investimenti diretti verso l’Italia, ma non solo. Sarà infatti cruciale rinsaldare il legame tra Stati Uniti e UE e fondare nuovi accordi di libero scambio per fronteggiare una concorrenza sempre più intensa e rafforzata da accordi tra paesi terzi, come ad esempio il Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) in Asia. Le sinergie prodotte da nuovi accordi commerciali internazionali, nonostante escludano l’Europa dai loro firmatari, dovrebbero essere comunque sfruttate dalle imprese italiane per rafforzare la loro posizione in quei mercati. Inoltre, la recente conclusione dell’accordo commerciale UE-MERCOSUR, sebbene manchino ancora alcuni passaggi formali per la sua entrata in vigore provvisoria (come per esempio l’approvazione del Consiglio e del Parlamento Europeo), prospetta importanti opportunità di ampliamento delle quote del Made in Italy nella regione, particolarmente per quanto riguarda la componentistica e la tecnologia, date le liberalizzazioni concesse dal Mercosur sui settori automobilistico, delle parti di automobili e dei macchinari.
Per una panoramica completa degli assi di intervento prioritari al fine di rilanciare la competitività dell’export di beni ACT si faccia riferimento alla Tabella B.

I macchinari ACT nell’era del “decoupling”. L’economia globale nel 2024 è profondamente segnata dalle crescenti tensioni commerciali e dalla competizione per la leadership tecnologica, con Stati Uniti e Cina al centro di una polarizzazione che sta rimodellando le catene di approvvigionamento globali e alterando gli equilibri economici internazionali. La “guerra commerciale”, avviata nel 2018, ha avuto conseguenze di vasta portata su diversi settori, specialmente quelli tecnologici e manifatturieri, spingendo sia la Cina che gli Stati Uniti a diversificare le proprie fonti di approvvigionamento. La competizione per il primato tecnologico ha anche indotto gli Stati Uniti a intensificare le politiche di reshoring e a ridurre la dipendenza dalle importazioni cinesi in settori chiave, come i semiconduttori e l’automazione.
Queste tensioni geopolitiche hanno contribuito al rallentamento del mercato europeo, già caratterizzato da una crescita economica debole e dall’aumento persistente dei costi energetici. Per il 2024, la crescita del PIL nell’UE è prevista all’1%, con un’accelerazione all’1,6% nel 2025. Il comparto manifatturiero rimane cauto, con una ripresa attesa solo nel medio termine, riflettendo l’incertezza delle prospettive economiche globali. Questa prudenza si manifesta in particolare nelle scelte di investimento: gli investimenti in macchinari e attrezzature hanno subito un calo significativo nella prima metà del 2024, contribuendo a una contrazione più ampia degli investimenti fissi lordi. Per l’intero 2024, gli investimenti in macchinari e attrezzature nell’UE sono previsti in contrazione dell’1,4%. Una moderata ripresa è attesa nel 2025, con una crescita degli investimenti stimata al 2% nell’UE e all’1,8% nell’area dell’euro. Questo miglioramento potrebbe essere accompagnato da un allentamento delle pressioni sui costi e ancora sostenuto dal supporto dei programmi dell’UE, come il Recovery and Resilience Facility (RRF), volto a promuovere la modernizzazione delle attrezzature industriali, l’adozione di tecnologie digitali e lo sviluppo di progetti infrastrutturali (Commissione Europea, 2024).
Il clima di crescente protezionismo, frammentazione geopolitica e competizione tecnologica ha implicazioni significative per il settore dei beni strumentali, inclusi i macchinari ACT (quelli a più elevato grado di automazione, creatività e tecnologia), che è particolarmente esposto a queste dinamiche globali. A livello europeo, il rapporto “The Future of European Competitiveness” evidenzia come i costi energetici elevati e la volatilità dei prezzi rappresentino una sfida significativa per la competitività dell’industria, particolarmente nei settori ad alta intensità energetica. Questo elemento ha un impatto diretto sul settore dei macchinari industriali, ancora alle prese con i contraccolpi della crisi energetica del 2022-2023, che ha spinto molte imprese a riorganizzare le loro strategie di produzione e approvvigionamento. In questo contesto, l’innovazione gioca un ruolo cruciale per rilanciare la competitività europea e italiana. Secondo il rapporto, la ricerca e l’innovazione (R&I) sono essenziali per aumentare la produttività e promuovere la crescita economica sostenibile. Gli investimenti in tecnologie avanzate e digitalizzazione non solo rafforzano la posizione delle imprese europee sul mercato globale, ma sono anche fondamentali per la transizione verde. Per il settore ACT, innovare significa sviluppare macchinari più efficienti dal punto di vista energetico e tecnologicamente avanzati, in linea con gli obiettivi climatici dell’UE. Promuovere la R&I, dunque, rappresenta una leva strategica per consolidare il vantaggio competitivo dell’industria italiana nei mercati internazionali e favorire una ripresa economica di lungo termine.
Nel 2023 e nei primi mesi del 2024, le esportazioni italiane di macchinari ACT hanno mostrato buone performance in mercati chiave come gli Stati Uniti, il Messico e la Turchia, compensando in parte le difficoltà incontrate in altre regioni come l’Asia del Pacifico e l’Europa. La riduzione della domanda interna in questi mercati e l’intensificarsi della concorrenza europea hanno contribuito a frenare la crescita delle esportazioni italiane. Tuttavia, l’industria ACT italiana ha mantenuto una posizione di rilievo sul piano competitivo in settori chiave, tra cui i sistemi meccatronici, i macchinari per la lavorazione della plastica e del legno e i robot per l’automazione.
I risultati preliminari dei primi sette mesi dell’anno indicano che il 2024 rappresenta un anno di stallo per l’export dei macchinari, soprattutto per l’importante componente che si rivolge al mercato europeo. I mercati del Nord America e del Medio Oriente hanno continuato a crescere, con incrementi rispettivamente del 1,4% e del 10,4% rispetto all’anno precedente. Al contrario, l’Asia orientale e l’Europa mostrano segnali di rallentamento, con cali rispettivamente del 5,2% e del 3,8%. Questi risultati non solo riflettono le dinamiche della domanda regionale, ma anche l’impatto delle politiche industriali e commerciali adottate dai paesi concorrenti. La crescente competizione nei settori tecnologici e industriali a livello globale sottolinea l’importanza per le imprese italiane di riorientare le loro strategie commerciali, puntando a consolidare la presenza nei mercati più dinamici e a diversificare le aree di esportazione per ridurre i rischi legati alla concentrazione geografica. Tra i settori più dinamici si distinguono le macchine per confezionamento e imballaggio, con un incremento rispettivamente del 19,3% nel 2023 e del 5% nei primi sette mesi del 2024 (rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente); e le macchine utensili, robot e automazione, le cui vendite sono cresciute del 23,8% nel 2023 e del 8,1% nei primi mesi del 2024.
La caratterizzazione del perimetro d’analisi: automazione, creatività e tecnologia (ACT) L’insieme di prodotti analizzati in questo capitolo si compone di 225 beni strumentali. L’individuazione di questi prodotti è stata realizzata attraverso una stretta collaborazione con le dodici associazioni di categoria affiliate a Federmacchine, un segmento fondamentale del settore dei macchinari industriali italiani, caratterizzato da un alto contenuto di innovazione tecnologica e automazione. Questa categoria rappresenta una parte significativa delle esportazioni italiane di beni strumentali, pari a circa il 30%, contribuendo in modo determinante alla competitività del paese sui mercati internazionali. L’analisi quantitativa si concentra su questi 225 prodotti di punta del settore ACT, attraverso una comparazione degli scambi internazionali che tiene conto delle specificità dei beni e dei mercati di destinazione. Prima di valutare il posizionamento italiano rispetto al commercio globale, si evidenzia il vantaggio competitivo degli esportatori italiani rispetto ai loro principali concorrenti internazionali, elemento centrale nella definizione del perimetro di riferimento. Questo vantaggio competitivo viene valutato non solo in termini di volumi di vendita, ma anche considerando i prezzi unitari, un indicatore chiave del premio di qualità riconosciuto ai prodotti italiani. Il posizionamento sui mercati esteri dei macchinari ACT italiani, quindi, non si limita alla quantità esportata ma riflette anche la capacità di mantenere prezzi più alti. Le Tabelle 1.1 e 1.2 forniscono una visione d’insieme del perimetro dei macchinari industriali di eccellenza, articolandoli nei diversi comparti industriali. Nella Tabella 1.1, vengono evidenziati il numero di “prodotti d’eccellenza”6 per ciascun comparto, la loro quota sul totale dei prodotti del settore e il numero di beni che ottengono un premio di prezzo (qualità) rispetto ai principali concorrenti. Complessivamente, i 225 prodotti identificati come macchinari industriali ACT rappresentano oltre un terzo delle esportazioni italiane di beni strumentali, sottolineando l’importanza di questo gruppo nell’economia export-oriented dell’Italia.
L’elevata competitività è il fattore distintivo dei macchinari Made in Italy. La Tabella 1.1 mostra che, nel 2022, per quasi tutti i prodotti del gruppo ACT (212 su 225) l’Italia si collocava nella fascia alta di competitività, ovvero nel top 25% dei paesi esportatori sia per valore sia per quantità. In termini di posizionamento generale, il nostro paese si colloca dietro solo a Cina, Germania, Giappone e Stati Uniti, mentre è davanti a Corea, Francia, Taiwan, Svizzera e Spagna. Tuttavia, è importante notare che per ben 97 di questi prodotti, l’Italia si colloca addirittura nel top 5% a livello mondiale, un risultato particolarmente significativo che riflette la forza del paese nel settore dei macchinari ad alta tecnologia. Nella distribuzione dei prodotti che godono di un vantaggio competitivo, i gruppi più rappresentati sono quelli dei Sistemi e componenti meccatronici per la trasmissione di potenza, e delle Macchine utensili, Robot e Automazione. Quest’ultimo include prodotti chiave come rettificatrici, fresatrici e torni, con ben 17 prodotti ad alta competitività. Inoltre, i comparti delle Macchine per calzature, pelletteria e conceria, Macchine per confezionamento e imballaggio, e Macchine e attrezzature per la lavorazione delle pietre naturali, si distinguono per l’elevata incidenza di prodotti di eccellenza. In questi comparti, infatti, una significativa quota di prodotti italiani rientra nel top 5% del commercio mondiale, dimostrando la capacità dell’Italia di mantenere una posizione di vertice in settori strategici per l’economia globale.

La Tabella 1.2 si concentra sulla componente di prezzo delle esportazioni italiane ACT ad alta competitività, discriminando i prodotti in funzione del prezzo relativo di vendita in ciascun mercato estero rispetto agli esportatori di grandi paesi dell’area euro quali Francia e Germania. Si parlerà di “premio di prezzo” se il prezzo relativo delle esportazioni italiane è più alto di quello di Francia e Germania; mentre si parlerà di “competitività di costo” se, a parità di prezzo, l’Italia esporta quantità sensibilmente più elevate. Avendo come benchmark un esportatore altamente competitivo nei macchinari come la Germania, in molti casi non si rileva un differenziale significativo di competitività. L’analisi rivela un’interessante eterogeneità nelle strategie di prezzo, anche all’interno di Uno stesso comparto. In settori come le Macchine utensili, robot e automazione (+22% in media); le Macchine e attrezzature per la lavorazione delle pietre naturali (+16%); o le Macchine per l’industria tessile (+19%) una quota significativa delle esportazioni si distinguono per un premio di prezzo sostenuto rispetto a Francia e Germania. Mentre, ad esempio, i settori come le Macchine e attrezzature per ceramica (-44%), le Macchine e materiali per fonderie (-43%) dimostrano una forte competitività in termini di costo.

Si contraggono le quote nei macchinari industriali ACT Come mostrato nella Tabella 1.3, negli anni dal 2018 al 2022, l’Italia ha registrato una leggera contrazione delle sue quote mondiali di export dei beni strumentali ACT. A fronte di una crescita mondiale del 2,3% annuo, le esportazioni italiane sono aumentate dello 0,4%, comportando una riduzione delle quote di mercato pari a 0,6 punti percentuali (p.p.). Questo calo è leggermente superiore a quello registrato dagli Stati Uniti (-0,4 p.p.) e Corea (-0,3 p.p.) ma molto inferiore rispetto al Giappone che ha visto contrarre le sue quote di mercato globali di 1,3 p.p. In Europa, la Germania ha registrato il calo più marcato -1,8 p.p., mentre la Francia ha subito un contrazione più moderata di quasi 0,5 p.p. Rimangono sostanzialmente stabili invece le quote della Spagna. L’osservazione delle sole quote di mercato può fornire una visione parziale della competitività internazionale di un paese. La dinamica delle quote di mercato, infatti, non dipende solamente dalla capacità competitiva del paese ma anche dalla sua specializzazione geografica e settoriale. Per isolare il contributo di ciascuno di questi elementi, seguiamo un approccio consolidato nella letteratura economica che combina una scomposizione ‘shift-share’ tradizionale con un approccio econometrico che stima il contributo di ciascuna dimensione alla dinamica delle esportazioni. Questa metodologia scompone la crescita delle esportazioni osservata in tre componenti principali: effetto di composizione geografica, che riflette il contributo dei mercati di destinazione; effetto di composizione settoriale, che misura il contributo dato dalla specializzazione nei settori; ed effetto di competitività, che cattura la vera capacità competitiva del paese isolata dalle dinamiche settoriali e geografiche. Comprendere queste dinamiche aiuta a formulare interventi di policy più mirati, indirizzando gli sforzi su quei fattori che possono migliorare effettivamente la competitività di un paese sui mercati internazionali.

Dalle colonne a, b e c della Tabella 1.3 si evince come, durante il quinquennio 2018-2022, la performance dell’Italia è stata principalmente influenzata da una contrazione della sua competitività relativa (-0,50 p.p.), parzialmente compensata da un contributo positivo (+0,03 p.p.) della composizione geografica, cioè della capacità dell’Italia di raggiungere mercati dinamici. Tuttavia, la composizione settoriale (-0,12 p.p.), ossia il mix di prodotti esportati, ha contribuito negativamente, risentendo del rallentamento della domanda globale. Tra i maggiori concorrenti, solo la Cina e l’India sono riusciti ad aumentare il loro peso sull’export globale di macchinari. La Cina ha in media annua una crescita delle esportazioni pari al +9%, guadagnando in modo deciso quote di mercato (+4,51 p.p.). Questo risultato è stato trainato da una competitività fortemente positiva (+5,09 p.p.). Anche l’India ha registrato una crescita delle esportazioni sostenuta, +10,2% in media annua, che le ha permesso di espandere le sue quote mondiali di beni ACT (+0,44 p.p.), tuttavia il suo peso mondiale è ancora relativamente contenuto pari al 1,76% dell’export mondiale di macchinari. Nel 2022, invece la Cina si è qualificata come il fornitore internazionale più competitivo per i 225 prodotti ACT, mentre l’Italia si è posizionata al quarto posto con una quota mondiale dell’8,2%, dietro alla Germania (17,8%) e al Giappone (9,3%). Tra gli altri grandi esportatori, Germania, Stati Uniti e Giappone hanno visto ridursi le loro quote di mercato a favore della crescita cinese. La Germania ha Subito una riduzione significativa delle quote di mercato (-1,77 p.p.), nonostante una composizione settoriale (+0,14 p.p.) e geografica (+0,20 p.p.) favorevoli, il deterioramento della competitività (-2,11 p.p.) ha determinato la forte contrazione delle quote di mercato. Sebbene partendo da un livello più basso anche la Francia ha registrato una contrazione marcata delle sue quote di mercato (-0,45 p.p.) completamente determinata dalla perdita di competitività del -0,50 p.p. Per gli Stati Uniti, la perdita di quote di mercato è stata più contenuta (-0,38 p.p.). Come per gli altri grandi esportatori europei, la dinamica negativa della competitività domestica ha giocato un ruolo cruciale nel determinare questa contrazione (-1,55 p.p.). Né la composizione settoriale (+0,23 p.p.) né l’orientamento geografico (+0,94 p.p.) sono stati sufficienti a controbilanciare la tendenza negativa.
Principali mercati di sbocco dei macchinari italiani ACT: USA, Europa e Cina Come riportato nel Grafico 1.1 i primi cinque mercati di destinazione delle esportazioni italiane di macchinari industriali ACT sono rappresentati da Stati Uniti (12%), Germania (10,3%), Cina (6,4%), Francia (6%) e Spagna (4%). Questi cinque paesi da soli assorbono più di un terzo delle esportazioni italiane di macchinari ACT, con una quota complessiva del 38,6%. Se si considerano i primi dieci mercati di destinazione, la quota sale al 54,5%, indicando una concentrazione significativa delle esportazioni italiane verso un numero relativamente ristretto di paesi, con un forte orientamento verso i principali mercati avanzati. Tra gli emergenti assumono un peso di assoluto rilievo il Messico, oggetto di un approfondimento dedicato nel Capitolo 4.

Polonia, India e Turchia svettano per dinamica delle proprie importazioni. Come riportato in Tabella 1.4, durante il quinquennio 2018-2022, la dinamica delle importazioni mondiali di macchinari ACT ha visto una crescita significativa in alcuni mercati emergenti, come la Polonia, l’India e la Turchia. Le importazioni di ACT in questi paesi sono aumentate rispettivamente del 4,0%, 6,3% e 7,5%, con conseguenti aumenti delle loro quote di importazioni mondiali di macchinari ACT pari a 0,17 p.p., 0,35 p.p. e 0,48 p.p. rispettivamente. Questi mercati emergenti stanno quindi assumendo un ruolo sempre più rilevante nella domanda globale di macchinari industriali. Nello stesso periodo, la Cina ha mostrato una contrazione nelle importazioni in valore di macchinari ACT, con un calo complessivo dell’1,4% nelle importazioni, che ha portato a una riduzione significativa della sua quota di mercato globale di quasi un punto percentuale, -0,88 p.p.
Nell’eurozona, Germania e Francia, che restano due dei principali mercati di sbocco per i macchinari italiani, hanno registrato una crescita modesta delle loro importazioni di ACT in termini assoluti, pari rispettivamente all’1,8% per la Germania e all’1% per la Francia. Tuttavia, questa crescita è risultata inferiore alla media mondiale, portando a una riduzione della loro quota di mercato globale: -0,26 p.p. per la Germania e -0,17 p.p. per la Francia. Questi dati indicano che, nonostante l’incremento della domanda interna, questi mercati hanno perso peso relativo nel commercio mondiale di macchinari ACT. Per quanto riguarda le esportazioni italiane verso questi mercati, si osserva che la dinamica in Germania, Francia e Spagna ha seguito una tendenza simile a quella mondiale, con una contrazione delle vendite italiane pari a -1,8% in Germania e -1,6% in Francia (tasso di crescita medio annuo). Tuttavia, gli Stati Uniti si distinguono come un mercato in espansione per le esportazioni italiane di ACT, con una crescita media annua del 3,8% nello stesso periodo.
L’Italia presidia bene i mercati a crescita più elevata. Guardando ai mercati più dinamici a livello globale, l’India si posiziona al primo posto con una crescita media annua delle importazioni mondiali pari al 6,3%. Attualmente, l’India rappresenta il 3,4% delle importazioni globali di macchinari ACT, mentre assorbe il 2,7% delle esportazioni italiane di questi beni. Sebbene il peso dell’India sulle esportazioni italiane sia in crescita, rimane leggermente inferiore alla media globale delle importazioni di ACT. Mentre la Cina ha registrato una contrazione delle importazioni mondiali di ACT pari a -1,4%, con una riduzione della sua quota globale del -0,88 p.p. Anche per gli esportatori italiani, il mercato cinese ha mostrato una leggera contrazione, con il 6,4% delle esportazioni italiane di ACT che sono destinate alla Cina nel periodo 2018-2022. Il Canada, al contrario, ha mostrato una crescita significativa nelle sue importazioni mondiali di ACT (+4,5%) con un incremento della quota di importazioni globali pari a 0,11 p.p., supportata da un aumento del valore della domanda (+0,12 p.p.). Tuttavia, il mercato canadese è ancora relativamente poco presidiato dagli esportatori italiani, che occupano solo l’1,4% delle esportazioni italiane di ACT, nonostante il Canada rappresenti il 2,8% della domanda globale di questi beni. Gli Stati Uniti continuano a essere un mercato fondamentale per i macchinari ACT, con una crescita delle importazioni globali del 4,3% e un incremento della loro quota di mercato di 0,89 p.p. Questo risultato è sostenuto da un forte aumento della domanda delle importazioni (0,85 p.p.). A livello globale, gli Stati Uniti rappresentano il 13,4% delle importazioni mondiali di ACT, mentre assorbono il 11,9% delle esportazioni italiane.
Mercati importanti per l’Italia come il Messico (2,5% delle esportazioni italiane di ACT) e la Polonia (3,8%) hanno avuto andamenti differenti. Mentre la Polonia ha visto crescere le sue importazioni globali del 0,17 p.p., il Messico ha registrato una crescita più modesta (+1,06%) accompagnata da un deterioramento dei fattori di domanda (-0,14 p.p.), che hanno portato ad una riduzione della quota di mercato globale -0,31 p.p. Le prospettive di operare in questo mercato restano comunque centrali, dato che potrebbe diventare una nuova base industriale per molte imprese che vogliano servire il mercato degli USA e del Canada.

Per numero di mercati presidiati, l’Italia si posiziona dietro solo a Cina e Germania. Il Grafico 1.2 evidenzia la performance dei beni strumentali ACT italiani, mostrando il numero di mercati presidiati dagli esportatori italiani attraverso un Indice di penetrazione dei mercati (asse orizzontale), espresso come una proporzione tra 0 e 100 (dove 100 rappresenta la copertura massima di tutti i mercati disponibili). L’asse verticale rappresenta il numero di esportatori che riescono a presidiare questi mercati con una quota di mercato superiore allo 0,5%. Considerando i 225 prodotti che fanno parte del gruppo ACT e i 216 paesi nel mondo, il numero teorico di mercati potenziali è di 48.600 (ovvero 216 combinazioni di paesi per 225 prodotti). Tuttavia, molti di questi mercati sono solo ipotetici poiché non vi è una domanda di importazioni. Quando si restringe l’analisi ai mercati effettivamente disponibili, ovvero quelle combinazioni paese-prodotto servite da almeno un esportatore, il numero totale di mercati potenziali scende a 42.510. La Cina raggiunge il massimo numero di mercati disponibili, coprendo 30.934 combinazioni prodotto-paese, che rappresentano il 72,8% del totale dei mercati potenziali. La posizione dominante della Cina è indicativa della sua presenza globale estesa e della capacità di competere su una vasta gamma di mercati internazionali.
In seconda posizione si trova la Germania, che raggiunge 22.761 mercati potenziali, pari al 53,5% del totale. La Germania, grazie alla sua consolidata tradizione industriale e al forte settore manifatturiero, riesce a mantenere una presenza significativa in gran parte dei mercati globali, anche se con una copertura inferiore rispetto alla Cina. L’Italia segue da vicino la Germania, raggiungendo 21.528 mercati, pari al 50,6% del totale delle combinazioni prodotto-paese disponibili. Questo risultato sottolinea la capacità degli esportatori italiani di competere in una vasta gamma di mercati, nonostante la presenza di grandi concorrenti globali. Il posizionamento dell’Italia, subito dopo Germania e Cina, dimostra la forza del settore ACT italiano, che si distingue per l’alta qualità e l’innovazione dei prodotti. Significativamente, l’Italia supera altri grandi paesi industrializzati in termini di mercati presidiati. Gli Stati Uniti, ad esempio, coprono 19.641 mercati, mentre la Francia ne raggiunge 14.459 e il Giappone 12.114. Questa differenza rispetto ad altri paesi avanzati evidenzia la maggiore capacità dell’Italia di adattarsi e penetrare in mercati più diversificati e difficili, sfruttando la sua competitività in segmenti di nicchia e in settori ad alta specializzazione. L’analisi complessiva suggerisce che, pur non essendo il primo esportatore in termini assoluti, l’Italia ha costruito una presenza robusta nei mercati globali, in grado di competere efficacemente con le altre grandi economie industriali come Cina e Germania.

Il Grafico 1.2 mostra il posizionamento competitivo dei principali paesi esportatori di macchinari ACT in base al numero di prodotti per cui ciascun paese è classificato come primo esportatore, tra i top 5 e tra i top 10 esportatori a livello globale. La Germania domina chiaramente, risultando primo esportatore per 53 prodotti e rientrando tra i top 10 per ben 207 prodotti, confermando così la sua leadership globale nel settore. Il Giappone segue da vicino, con 44 prodotti per cui è il primo esportatore e una presenza significativa tra i top 10 con 192 prodotti. La Cina si distingue per la sua forte presenza tra i top 5 (149 prodotti) e top 10 (198 prodotti), con 30 prodotti in cui è il principale esportatore.

L’Italia si posiziona in maniera competitiva, con 18 prodotti per i quali è il primo esportatore e un posizionamento tra i top 5 e top 10 rispettivamente per 115 e 176 prodotti. Questo dimostra come gli esportatori italiani riescano a mantenere una presenza rilevante tra i principali esportatori su una vasta gamma di prodotti. Paesi come gli Stati Uniti e la Corea hanno una presenza più limitata, con solo 2 e 1 prodotti rispettivamente in cui sono primi esportatori, ma riescono comunque a rientrare nei top 10 per un numero significativo di prodotti (121 per gli Stati Uniti e 127 per la Corea). La Svizzera, Taiwan e l’Austria mostrano una presenza più specializzata, con un numero più limitato di prodotti in cui sono competitivi, mentre la Francia si posiziona tra i top 10 esportatori per 51 prodotti, ma è primo esportatore per uno solo.
Crescita stabile delle esportazioni italiane tra il 2023 e i primi mesi del 2024. Il Grafico 1.4 rappresenta l’andamento mensile delle esportazioni di macchinari ACT per Italia, Germania e Francia, esprimendo la variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Le serie mensili evidenziano una significativa volatilità, caratteristica comune a tutti e tre i paesi analizzati.
Durante il 2019, i tre paesi mostrano oscillazioni simili, seppur con andamenti divergenti in alcuni mesi. Tuttavia, con l’arrivo della pandemia di COVID-19 nel 2020, si osservano bruschi cali in tutti e tre i paesi, con variazioni negative di oltre il -50% per l’Italia in aprile 2020, seguito da riduzioni significative anche per Germania e Francia, segnalando l’impatto grave delle restrizioni globali al commercio. Il 2021 segna un forte recupero per tutti i paesi. In particolare, l’Italia registra un aumento molto marcato delle esportazioni in aprile (+116,4%), seguito da crescite sostenute nei mesi successivi, anche superiori a quelle di Germania e Francia. Questo rimbalzo particolarmente pronunciato può essere attribuito alla riapertura graduale dei mercati e alla ripresa della domanda globale di macchinari e beni strumentali. La Germania e la Francia, pur registrando crescite elevate, si posizionano dietro l’Italia in termini di variazione percentuale, specialmente nei mesi centrali del 2021.
Nel 2022, si osserva un rallentamento generale della crescita, con diverse flessioni mensili per i tre paesi, segnalando un ritorno alla normalizzazione dopo i picchi post-pandemia.

Il recupero post-pandemico. Nonostante ciò, l’Italia continua a mantenere una performance competitiva, soprattutto nei mesi di novembre 2022 (+15,7%) e dicembre 2022 (+13,8%), rispetto a Germania e Francia. Nel 2023, l’export italiano mantiene una crescita costante, con un incremento particolarmente forte fra gennaio (+16,2%) e marzo (+15,8%), mentre Germania e Francia continuano a mostrare dinamiche positive, ma generalmente con tassi di crescita inferiori a quelli italiani nel primo trimestre 2023. Tuttavia, i dati di maggio e giugno 2024 evidenziano un rallentamento generalizzato per tutti e tre i paesi, a indicare una possibile fase di raffreddamento dell’economia globale.
Le Macchine e attrezzature per la lavorazione delle pietre naturali e le “Macchine utensili, robot e automazione” tra i settori più dinamici nel 2024. La Tabella 1.5 mostra l’andamento delle esportazioni dei principali settori dei macchinari industriali italiani dal 2019 al 2023. La dinamica pluriennale evidenzia un periodo di grande volatilità, segnato da una forte contrazione nel 2020 a causa dell’impatto della pandemia di COVID-19, seguito da un rimbalzo significativo nel 2021 e 2022. I settori hanno risposto in modo diverso alle sfide globali, con alcuni comparti che hanno registrato una ripresa più marcata, mentre altri hanno avuto una crescita più contenuta o una flessione più prolungata.
Nel 2020, quasi tutti i settori hanno registrato flessioni significative, con cali che hanno raggiunto picchi del -29% per le Macchine per calzature, pelletteria e conceria e del -26% per le Macchine e attrezzature per la lavorazione delle pietre naturali. Tuttavia, nel 2021, si è osservato un forte rimbalzo in quasi tutti i comparti, con crescite che in alcuni casi hanno superato il 40%, come nel caso delle Macchine per la lavorazione del legno (+41,1%) e delle Macchine per l’industria tessile (+56,8%). Queste tendenze riflettono la ripresa della domanda globale, spinta dalla riapertura dei mercati e dalla necessità di macchinari avanzati per sostenere la ripartenza economica.
Nel 2022, la dinamica di crescita si è stabilizzata, con alcuni settori che hanno continuato a registrare buone performance, come le Macchine e attrezzature per la lavorazione delle pietre naturali (+26,9%) e le Macchine per l’industria tessile (+21,6%), mentre altri comparti hanno mostrato una crescita più contenuta, come le Macchine per la lavorazione del legno (+4,3%) o non hanno registrato variazioni significative dei volumi rispetto all’anno precedente, come le Macchine per confezionamento e imballaggio (+0%).
L’anno 2023 ha visto una diversificazione ancora maggiore tra i settori, con alcuni comparti che hanno mantenuto una buona crescita, come le Macchine utensili, robot e automazione (+23,8%) e le Macchine per confezionamento e imballaggio (+19,3%), mentre altri hanno subito una frenata, come le Macchine per l’industria tessile (-17,7%) e le Macchine e accessori per il vetro (-3%).

Nei primi mesi del 2024, come rivelato dal Grafico 1.5, si osserva una continuazione di queste tendenze. Nel complesso, le esportazioni di macchinari ACT si sono leggermente contratte, -1,7% rispetto agli stessi mesi del 2023, ma la dinamica aggregata nasconde una grande eterogeneità settoriale. Mentre settori come le Macchine per la lavorazione delle pietre naturali (+19,9%) e le Macchine utensili, robot e automazione (+8,1%) hanno continuato a espandersi, altri comparti hanno registrato contrazioni significative, come le Macchine e attrezzature per ceramica (-31,4%) e le Macchine e materiali per fonderie (-10%).

Ottima performance per le Macchine e attrezzature per la lavorazione delle pietre naturali. In linea con i risultati degli anni post-pandemia, il settore delle Macchine e attrezzature per la lavorazione delle pietre naturali mostra una crescita del +19,9% nei primi mesi del 2024 (gennaio-luglio). Al centro della dinamica positiva del comparto, le Mole abrasive le cui esportazioni sono aumentate di 6,6 volte rispetto all’anno precedente.
Buona performance per le Macchine utensili, robot e automazione. Il settore delle Macchine utensili, robot e automazione registra una crescita del +8% nei primi mesi del 2024 (gennaio-luglio). Questo risultato è stato favorito dall’aumento della domanda di automazione e robotica industriale, con settori come la lavorazione automatizzata di materiali e la robotica avanzata che hanno contribuito in modo sostanziale alla ripresa. Alcuni dei prodotti principali in questo recupero sono, per esempio, i Torni verticali a comando numerico, che hanno registrato una crescita del +32,1%, e le Macchine utensili operanti, in crescita del +18,7%.
Settori in crescita e settori in contrazione: i risultati per l’Italia nel confronto internazionale. Nel 2024, i settori dei macchinari ACT italiani presentano una dinamica contrastante rispetto a quelli di Francia e Germania, con alcuni comparti in crescita e altri più in difficoltà. Il settore delle macchine per la lavorazione delle pietre naturali mostra una crescita significativa per l’Italia, con un incremento del +19,9%, nettamente superiore alla performance negativa della Francia (-12,2%) e della Germania (-13,3%). Anche il comparto delle macchine utensili, robot e automazione registra un buon andamento per le esportazioni italiane (+8%), rispetto a variazioni negative per entrambi i concorrenti europei (Francia -3,6% e Germania -5%).
D’altra parte, i settori delle Macchine e attrezzature per ceramica e le Macchine e materiali per fonderie mostrano segni di difficoltà, con variazioni rispettivamente del -31,4% e -10% per l’Italia, che risultano, in media, inferiori ai concorrenti.
Valori registrati dalla Francia e dalla Germania in questi stessi comparti (con l’eccezione delle esportazioni francesi di macchinari e materiali per fonderie che registrano -16%). Anche il comparto delle macchine per calzature, pelletteria e conceria ha subito una contrazione significativa, con un calo del -7,6%, ma meno accentuato rispetto alla Francia (-41,4%) e alla Germania (-21,5%). Sul fronte delle macchine per confezionamento e imballaggio, l’Italia mantiene una crescita positiva (+5%), sebbene inferiore rispetto ai forti incrementi di Francia (+19%) e Germania (+6,7%).
L'area dell'America Settentrionale e quella del Nord Africa e del Medio Oriente trainano la crescita nel 2024. Sotto il profilo geografico, riportato nella Tabella 1.6, i mercati del Nord America e del Medio Oriente e Nord Africa si confermano le destinazioni più dinamiche per le esportazioni di macchinari ACT nei primi sette mesi del 2024. L’America del Nord, dopo un buon risultato nel 2023 (+9,2%), ha continuato a crescere a un ritmo moderato (+1,4%), mantenendo comunque una tendenza positiva. Il Medio Oriente e Nord Africa ha registrato la crescita più significativa, con un aumento del +10,4% nel 2024, trainato dalla ripresa economica post-pandemica e dall’aumento della domanda di infrastrutture.
L’Europa e l’Asia Centrale, pur avendo mostrato una crescita moderata nel 2023 (+6,8%), hanno subito una flessione del -3,8% nei primi mesi del 2024, probabilmente a causa delle incertezze geopolitiche e del rallentamento della domanda in alcune economie chiave dell’area. Nonostante ciò, l’Europa rimane un mercato stabile per le esportazioni italiane di macchinari ACT, anche se la crescita è stata inferiore rispetto ad altre aree.
In altre regioni, l’Asia del Sud, che aveva registrato una forte crescita nel 2021 (+50,3%), ha mostrato segni di rallentamento, con un -3,6% nei primi mesi del 2024, evidenziando una stabilizzazione della domanda. L’ALC, dopo aver beneficiato di una crescita del +14,6% nel 2023, hanno registrato una leggera flessione nel 2024 (-2,7%), riflettendo un rallentamento nella ripresa economica della regione.
L’Asia Est e Pacifico e l’Africa Sub Sahariana, entrambe regioni che hanno mostrato volatilità, hanno subito contrazioni nel 2024. L’Asia Est e Pacifico ha registrato un calo del -5,2%, evidenziando le difficoltà delle economie di questa regione nel sostenere la domanda di macchinari ACT. L’Africa Sub Sahariana, dopo un buon risultato nel 2023 (+18,1%), ha segnato un aumento più contenuto nei primi mesi del 2024 (0,8%), ma rimane comunque una regione di potenziale crescita per le esportazioni italiane.

Nonostante la dinamica positiva del Medio Oriente e Nord Africa, il peso relativo della regione sull’export totale di ACT italiani è ancora relativamente limitato, 5,8% del totale esportazioni ACT. La buona dinamica dell’America del Nord è un segnale decisamente positivo, considerando il peso del mercato, 14,3% del totale export ACT; mentre il rallentamento europeo può avere un impatto importante sulle esportazioni considerando che il 55,6% delle esportazioni ACT viene assorbito in Europa e Asia Centrale.
Nel complesso, le esportazioni italiane di macchinari ACT continuano a performare bene in aree come il Nord America e il Medio Oriente, dove l’Italia riesce a mantenere una posizione competitiva rispetto ad altri principali esportatori. Tuttavia, in altre regioni come l’Asia del Sud e l’Europa, l’andamento è più moderato e riflette le complessità del contesto geopolitico ed economico globale.
ACT allineato ai competitor europei in Europa ed Asia centrale, in ritardo nelle altre regioni. Il Grafico 1.6 mostra la variazione percentuale delle esportazioni di macchinari ACT nei primi mesi del 2024, confrontando la performance italiana con quella dei principali competitor europei, Francia e Germania, nelle principali aree geografiche. La performance complessiva rivela una situazione di chiaro allineamento nei mercati di Europa ed Asia Centrale, dove le esportazioni italiane (-3,8%) risultano abbastanza vicine a quelle di Germania (-7,9%) e Francia (-1,7%), in un contesto generale di rallentamento economico nella regione. Tuttavia, il posizionamento dell’Italia risulta più debole in altre aree. In Asia Est e Pacifico, la Francia domina con una crescita del +15,3%, mentre Germania (-8,3%) e Italia (-5,2%) mostrano una contrazione significativa.
America Latina e Caraibi evidenzia un divario rilevante: mentre la Germania registra una crescita del +14,7%, seguita dalla Francia con una crescita del +2,9%, l’Italia rimane in territorio negativo (-2,7%). Anche nel Medio Oriente e Nord Africa, una regione in forte crescita, la performance italiana (+10,4%) è buona ma inferiore rispetto alla Francia (+17%) e alla Germania (+21,5%). In America del Nord, l’Italia cresce a un ritmo più lento (+1,4%) rispetto alla Francia (+7,3%) ma quasi il doppio della Germania (+0,9%). In Asia del Sud, la Francia continua a prevalere con un +10,8%, mentre Germania (-2,3%) e Italia (-3,6%) mostrano una contrazione delle esportazioni. Infine, l’Africa Sub Sahariana mostra una crescita positiva per la Germania (+4%) e l’Italia (+0,8%), mentre la Francia rimane leggermente indietro con un calo del -1,2%.

Nel 2024 l’ACT cresce particolarmente negli Stati Uniti, in India e in Turchia. Il Grafico 1.7 illustra le variazioni percentuali delle esportazioni di macchinari ACT verso i principali mercati di destinazione nei primi mesi del 2024, confrontando la crescita rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. I risultati evidenziano una buona performance in mercati strategici come gli Stati Uniti, l'India e la Turchia, che si confermano trainanti per l’export italiano di macchinari ACT.
Gli Stati Uniti, che rappresentano il mercato principale per i macchinari italiani con una quota del 12,7%, hanno registrato una crescita del +1,8% nel 2024, proseguendo il trend positivo già osservato nel 2023. Gli Stati Uniti rimangono un mercato fondamentale, grazie alla crescente domanda di tecnologie industriali avanzate e automazione, dove le aziende italiane continuano a essere fortemente competitive. La Turchia ha mostrato la crescita più significativa tra i mercati principali, con un aumento del +5,6%, confermandosi un mercato in espansione per i macchinari italiani, con una quota del 4% sull’export totale. Anche l’India ha registrato una crescita importante, del +3,5%, mantenendo una quota del 3,1% sull’export totale.
Al contrario, i mercati tradizionali europei, come la Germania e la Francia, hanno mostrato segni di debolezza. Le esportazioni italiane verso la Germania sono diminuite del -5,2%, mentre quelle verso la Francia hanno subito una contrazione del -4,3%. Nonostante ciò, entrambi i mercati rimangono tra i principali per l’export italiano, con la Germania che rappresenta una quota dell’11,2% e la Francia il 6,9%. Più preoccupante è la situazione in Cina, dove le esportazioni italiane hanno subito un forte calo del -9,8%. Con una quota del 4,7% sull’export totale, la Cina rimane comunque un mercato di grande importanza strategica, ma il calo riflette le difficoltà economiche e le tensioni commerciali che stanno rallentando la domanda per macchinari industriali. Infine, il Regno Unito ha mostrato una marcata contrazione, con un calo del -3,5%, confermando le difficoltà del mercato britannico post-Brexit. Anche se il Regno Unito rappresenta una quota del 3,2%, il contesto economico sfavorevole rende più difficile il recupero delle esportazioni italiane verso questa destinazione.

Andamento settoriale nei mercati più rilevanti nel 2024. Nel 2024, le esportazioni di macchinari ACT italiani hanno mostrato dinamiche molto diverse tra i principali settori e mercati. Gli Stati Uniti, il Messico e la Turchia si confermano mercati trainanti per diversi settori, mentre in Cina si osservano forti contrazioni in alcuni comparti chiave.
In Cina, il settore delle Macchine per l’industria tessile ha registrato una crescita eccezionale del +69,3% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, con una quota del 12% sulle esportazioni italiane verso questo mercato. Altri settori chiave come i Sistemi e componenti meccatronici per la trasmissione di potenza (-12,5%) e le Macchine utensili, robot e automazione (-12,5%) hanno registrato una contrazione significativa.
In Francia, il settore delle Macchine per la lavorazione del legno si è distinto con una crescita del +23,5%, mentre le Macchine e stampi per materie plastiche e gomma hanno registrato un solido +10,9%. Il comparto delle Macchine per confezionamento e imballaggio, tuttavia, ha mostrato una leggera flessione (-5,7%), nonostante rimangano un settore centrale per le esportazioni italiane in Francia, con una quota del 19,6%. In Germania, le Macchine per confezionamento e imballaggio sono cresciute del +5,8%, confermando la robustezza di questo settore nel mercato tedesco, che rappresenta una quota del 9,8% delle esportazioni italiane verso questo paese. Le Macchine utensili, robot e automazione hanno registrato un incremento del +14,1%, mentre altri settori, come i Sistemi e componenti meccatronici per la trasmissione di potenza, hanno visto una contrazione significativa (-12,3%), segnalando una riduzione della domanda per questo tipo di macchinari in Germania.
In Turchia, le Macchine e accessori per il vetro hanno registrato una crescita eccezionale del +38,5%, seguite dalle Macchine per confezionamento e imballaggio (+32%) e dalle Macchine e stampi per materie plastiche e gomma (+20%). La Turchia si conferma un mercato in forte espansione per i macchinari italiani, sostenuto dall’industrializzazione in corso e dalla crescente domanda di tecnologie industriali. Anche i Sistemi e componenti meccatronici per la trasmissione di potenza hanno visto una crescita del +4,2%, contribuendo a rafforzare la presenza italiana in questo mercato.
Negli Stati Uniti, le Macchine utensili, robot e automazione hanno registrato una crescita significativa del +11,8%, così come i “Sistemi e componenti meccatronici per la trasmissione di potenza” anch’essi con una crescita a due cifre, +10,5%, confermando l’interesse americano per tecnologie industriali avanzate. Al contrario, le Macchine per confezionamento e imballaggio hanno subito una contrazione del -2,2%, nonostante rappresentino ancora una parte importante delle esportazioni italiane verso gli Stati Uniti, con una quota del 22,4%.
L’Africa è da sempre considerata un’area chiave per le prospettive future di sviluppo economico a livello mondiale. Le ultime previsioni in termini di crescita del prodotto interno lordo (PIL) del continente risultano incoraggianti. Nel dettaglio, il PIL reale è previsto in crescita fino al 3,7% nel 2024 ed è ulteriormente stimato in ascesa al 4,3% nel 2025. Questi dati posizionano il continente africano al secondo posto dietro solo all’Asia, in termini di crescita del PIL reale, tra le principali aree economiche mondiali.
Le prospettive di crescita dell’Africa risiedono principalmente nella sua struttura demografica e nell’alta concentrazione di risorse naturali. L’industrializzazione della regione è però ancora lontana dal rendere la regione pienamente integrata nelle catene globali del valore. Infatti, due dei principali obiettivi indicati dall’African Development Bank Group nel suo “piano decennale” risultano l’industrializzazione del continente e la sua concomitante integrazione nelle catene del valore aggiunto globale.
Uno dei fattori chiave per l’avanzamento tecnologico e industriale dell’Africa è rappresentato dal commercio internazionale. Uno sguardo d’insieme sul posizionamento dell’Africa all’interno del contesto commerciale internazionale mostra come l’Unione Europea, nel suo insieme, risulti ancora uno dei principali esportatori anche se la sua quota è diminuita negli ultimi anni. Lo spazio commerciale lasciato dall’Unione Europea è stato prontamente riempito, a partire dal 2015, dall’Asia che in pochi anni è diventata il principale esportatore a livello globale. Nel dettaglio, nel 2023, l’Unione Europea ha fatto segnare una quota export pari al 21,6%, in lieve aumento rispetto al 21,4% del 2022, mentre l’Asia ha visto il suo peso crescere al 32,9% dal 30,8% fatto registrare nel 2022. L’import africano dall’Asia si concentra principalmente in macchinari, apparecchi elettrici, elettronica, petrolio e altri combustibili minerali, veicoli e materie plastiche. In totale la quota dell’export detenuta da queste categorie di prodotto si attesta al 64,9% nel 2023, segnando una crescita percentuale del 52,9% dal 2022.
Lo sviluppo industriale dell’Africa non può prescindere, almeno in questa fase di industrializzazione embrionale, dall’importazione di macchinari. Alla luce dei numeri d’insieme presentati poco sopra, è immediato chiedersi quale sia il ruolo del comparto dei macchinari ACT per il continente africano. Di seguito presentiamo una panoramica su questo punto. L’analisi che segue tiene conto anche di alcuni partner strategici facenti parte dell’area del Vicino Medio Oriente.
Cresce il peso dell’Africa come mercato di sbocco dei macchinari. Al 2018 la quota del settore dei macchinari ACT sull’export totale nella regione considerata si attestava al 4,3%. Negli ultimi cinque anni questa quota è aumentata a 4,8% nel 2022 (Grafico 1.8). Il Grafico 1 mostra, in aggiunta, la struttura di questa quota per i diversi settori considerati. Si vede chiaramente come quattro settori spicchino per dimensione: macchinari per la trasmissione di potenza (30,5% al 2022), macchine per vetro (14,1% al 2022), macchine per plastica e gomme (14,3% al 2022) e macchine per imballaggio (11,9% al 2022).

Le economie del Golfo e il Sud Africa rappresentano circa i due quinti delle esportazioni ACT nella regione. Nel dettaglio, per quanto riguarda i principali importatori di macchinari ACT, Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita e Sud Africa dominano per quota di assorbimento dell’export ACT (Grafico 1.9), con una quota cumulata del 38,7%. La crescita delle quote degli stati del Golfo si è accompagnata a una riduzione delle quote dei principali importatori continentali quali lo stesso Sud Africa (da 13,1% nel 2018 a 11,9% nel 2022), Egitto (da 10,3% a 9,5%) e Algeria (da 9,5% a 5,2%).

L’Italia si conferma il terzo maggior esportatore di beni ACT in Africa e Vicino Medio Oriente. La quota dell’export totale italiano in Africa e Medio Oriente riferita al comparto dei beni ACT si attesta nel 2022 al 9,6% in flessione rispetto al 2018, dove la quota si attestava al 12,6%, del 3,7%. Questo posiziona l’Italia al terzo posto come principale esportatore di beni ACT nell’area (Grafico 1.10). Nonostante la flessione, l’Italia mantiene il suo ruolo come uno dei principali esportatori nell’area dietro solo alla Cina e alla Germania. Tra i principali esportatori del settore, solo la Cina ha però incrementato la propria quota tra il 2018 e il 2022 (+56,4%), passando dal 18,8% al 29,4% e conquistando quindi circa un terzo del mercato della regione.


Volgendo ora lo sguardo alla composizione dell’export italiano ACT nell’area, questo risulta fortemente concentrato nel settore delle macchine per confezionamento e imballaggio; nel 2023 questo comparto detiene una quota significativa del 28,5% (Grafico 1.11). Nel quinquennio considerato, crescono le quote delle macchine e accessori per il vetro (+20,3%), le macchine e stampi per materie plastiche e gomma (+17,5%), i sistemi e componenti elettronici per la trasmissione di potenza (+43,4%) e le macchine per l’industria tessile (+48,4%).
Le grandi economie del nord Africa – Algeria ed Egitto – si confermano i principali partner commerciali; in crescita gli Emirati Arabi e il Sud Africa. Il Grafico 1.12 fornisce una panoramica sui principali partner commerciali nel comparto ACT per peso sull’export di macchinari italiani nella regione. È evidente il netto calo dell’Algeria come partner principale, con una quota che scende dal 21,8% nel 2018 al 15,9% nel 2023. Anche l’Egitto, altro storico partner italiano nella regione, ha registrato una contrazione della propria quota dal 17,7% nel 2018 al 15,8% nel 2023. La contrazione delle quote di questi due storici partner si affiancano a una decisa espansione degli Emirati Arabi Uniti, con una quota che passa dall’11,3% nel 2018 al 13,6% nel 2023. Cresce anche il peso del Sud Africa, dal 9,7% al 12,7% (+30,1%), del Marocco, dal 7,9% al 10,0% (+26,6%) e della Tunisia, dal 6,7% al 7,5% (+11,9%).

Quali nuove opportunità di export per l’Italia? L’obiettivo di questo capitolo è di approfondire e analizzare quali potrebbero essere le future opportunità per l’export italiano di macchinari nel campo dell’automazione, creatività e tecnologia (ACT). L’analisi presenta i risultati della quantificazione del potenziale di export nei diversi mercati e categorie di prodotto, e consente l’individuazione dei principali concorrenti. Trasformare il potenziale in export effettivo è un obiettivo ambizioso, che implica un aumento della competitività da un lato e il saper cogliere le opportunità che si presenteranno dall’altro. Inoltre, le imprese dovranno muoversi all’interno di un contesto internazionale in rapido mutamento e di non facile lettura, che ha necessariamente implicazioni rilevanti per le opportunità di export che emergono dall’analisi.
Le prospettive globali sono caratterizzate da elevata incertezza. Le stime di crescita del PIL mondiale per il 2025 indicano valori intorno al 3,2%; le prospettive di crescita sono stabili ma sostanzialmente modeste (FMI). Ci si attende una performance relativamente migliore degli Stati Uniti rispetto all’Europa. In Medioriente, anche a causa dei conflitti, resta elevato il rischio di problemi legati agli approvvigionamenti e alle spedizioni. Viceversa, i paesi emergenti dell’Asia, specificamente il Sud Est Asiatico trainato dalla Cina, presentano proiezioni di crescita più elevate, trainate dalla domanda di semiconduttori ed elettronica e dagli investimenti in intelligenza artificiale. A livello globale l’inflazione sarà inferiore al 4,5%, risultando ormai sostanzialmente sotto controllo in molti paesi. Le principali fonti di incertezza, invece, riguardano i conflitti e le tensioni geopolitiche. La vittoria di Donald Trump alle elezioni presidenziali degli Stati Uniti rappresenta un’ulteriore possibile fonte di incertezza per quanto riguarda il commercio internazionale in considerazione degli elevati dazi promessi in campagna elettorale, compreso nei confronti di beni italiani ed europei.
Le difficoltà dell’industria automobilistica e il passaggio ai veicoli elettrici. Un altro elemento che sta caratterizzando il quadro internazionale di potenziale interesse per il settore ACT riguarda l’evoluzione del settore automotive. L’adozione crescente dei veicoli elettrici (EV) sta trasformando profondamente l’industria automobilistica globale, incidendo su investimenti, produzione, commercio internazionale e occupazione. Il passaggio agli EV rappresenta una sfida per l’automotive europeo e il suo indotto, a causa degli alti costi di produzione e della forte concorrenza dei produttori asiatici. La crisi del settore automobilistico tedesco potrebbe avere importanti ripercussioni anche in altri paesi europei, Italia inclusa. I comparti dei macchinari legati alla produzione automobilistica, come macchine utensili, robot e automazione, sono coinvolti in questa transizione e affrontano sia rischi sia opportunità.
In questo capitolo si utilizzano i dati di commercio mondiale per valutare quali siano gli spazi aggiuntivi per le imprese ACT e su quali mercati concentrare l’attenzione per la realizzazione del potenziale.
Misurare il potenziale sfruttabile, ovvero l’export addizionale ottenibile rispetto ai concorrenti più simili.
Un elemento fondamentale per questa analisi risiede nell’individuazione dei concorrenti effettivi, cioè dei paesi esportatori simili all’Italia per caratteristiche e prodotti esportati. Tra questi, risultano di particolare interesse quelli che, a parità di condizioni, ottengono risultati migliori in termini di export. Nello specifico, questa operazione di individuazione dei concorrenti simili viene svolta all’interno di ogni mercato di destinazione e per ogni categoria di prodotto dell’ACT. Per poter individuare efficacemente i paesi esportatori simili all’Italia si utilizzano alcune delle principali misure adottate nella letteratura economica. In particolare, consideriamo: le quote di mercato, i prezzi (valori medi unitari), la distanza geografica, il grado di specializzazione, la diversificazione dell’export, la sostituibilità dei beni esportati ovvero il loro grado di unicità, e il reddito pro-capite. Una volta individuati i concorrenti più simili all’Italia per ogni tipologia di prodotto in ogni mercato di destinazione, costruiamo una misura della domanda aggiuntiva che potrebbe essere soddisfatta dalle aziende italiane, trasformandosi in potenziale export aggiuntivo. Il potenziale così identificato rappresenta lo spazio di manovra in cui le aziende italiane possono muoversi per erodere quote ai concorrenti più simili. La parte davvero contendibile è però limitata dall’attuale capacità produttiva delle imprese italiane e dalla possibilità di poterla ampliare nell’orizzonte temporale di un quinquennio. In tal senso, per ogni mercato di sbocco, viene altresì calcolato il potenziale aggiuntivo effettivamente contendibile o realizzabile nel medio periodo – in altre parole, la quota dello spazio di manovra che può essere realisticamente coperta dalle imprese italiane – nell’assunzione che vengano effettuate scelte di investimento tali da determinare un miglioramento della competitività sui mercati esteri, accompagnato da un aumento della capacità produttiva e, quindi, un aumento della quota di mercato. Nello scenario più ottimistico di realizzazione del potenziale si assume anche che vengano regolarmente esaurite le scorte di magazzino per far fronte all’aumento della domanda di macchinari italiani. In generale, l’esistenza di un differenziale positivo tra export potenziale complessivo ed export effettivo indica che esistono margini di miglioramento nella capacità di penetrare i mercati esteri.
La dicotomia tra economie avanzate ed emergenti per il potenziale dell’export italiano. L’analisi svolta in questo capitolo è presentata separatamente per i mercati avanzati e quelli emergenti. La scelta deriva dal fatto che i paesi appartenenti ai due gruppi presentano caratteristiche molto diverse, specialmente per quanto riguarda le capacità di penetrazione dell’export italiano: le economie mature dei paesi avanzati hanno mercati grandi in valore, un reddito pro-capite elevato, e in esse il settore dei prodotti dell’ACT gode già di un posizionamento relativamente consolidato; viceversa, i paesi emergenti, salvo eccezioni, hanno mercati interni più piccoli in valore, un reddito pro-capite mediamente inferiore, e il comparto dei beni dell’ACT presenta ancora un elevato margine di miglioramento, sia per ragioni legate allo sviluppo economico dei singoli paesi sia per ragioni storico-culturali, anche in considerazione di diversità nei sistemi legali e negli standard tecnologici.
In breve: come leggere i potenziali di export
Il potenziale di export o potenziale realizzabile rappresenta l’export aggiuntivo realizzabile in un’ottica di medio periodo. Per agevolare i confronti, il potenziale realizzabile può essere espresso in percentuale dell’export effettivo corrente definendo così un indice di contendibilità. Infine, oltre al potenziale realizzabile, si identifica uno spazio di manovra che rappresenta il valore di mercato nel quale le aziende italiane possono muoversi al fine di erodere ulteriori quote ai concorrenti più simili.
Per comodità, si riportano di seguito alcune definizioni:
• Potenziale realizzabile (€): export aggiuntivo ottenibile oltre l’export effettivo;
• Indice di contendibilità (%): potenziale / export × 100;
• Spazio di manovra (€): spazio di export contendibile rispetto a paesi simili.
Il valore del potenziale non è una previsione circa la possibile evoluzione futura delle vendite, la quale dipende in primo luogo dalla capacità degli esportatori di cogliere le opportunità, dalla congiuntura e dalle condizioni macroeconomiche. Questi aspetti, più altre valutazioni qualitative, sono discussi nel capitolo a complemento dell’analisi quantitativa di misurazione del potenziale.
Gli Stati Uniti rappresentano il mercato con il maggior potenziale in termini assoluti, con un’opportunità di export aggiuntivo stimata in 760 milioni di euro. Il Grafico 2.1 evidenzia il potenziale di export italiano verso i principali mercati avanzati, mostrando come l’elevato potenziale degli Stati Uniti sia principalmente dovuto alle vaste dimensioni del mercato. Questo lascia ampio margine per l’espansione delle esportazioni italiane negli USA, sfruttando l’attrattività del Made in Italy rispetto ai principali concorrenti. Tuttavia, è fondamentale considerare le possibili difficoltà legate alle politiche commerciali che potrebbero essere introdotte dalla nuova presidenza americana: durante la campagna elettorale, infatti, il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha spesso prospettato l’introduzione di dazi molto elevati, anche nei confronti dell’Unione Europea, per proteggere l’economia interna e potenzialmente ridurre l’ampio deficit commerciale del Paese nei confronti di molti partner commerciali. Questo scenario genera un clima di forte incertezza per le prospettive di export e richiede un’attenta osservazione nel prossimo futuro, poiché tali politiche potrebbero limitare la realizzabilità del potenziale. Considerando l’intero mercato nordamericano, inoltre, il potenziale di export italiano risulta ancor più significativo, con un’opportunità aggiuntiva stimata di 150 milioni di euro in Canada.

Il potenziale di export è particolarmente elevato in Germania, Francia e Austria, mercati che complessivamente offrono un’opportunità stimata di 1,31 miliardi di euro. Dal Grafico 2.1 emerge che la Germania, da sempre una destinazione primaria per i prodotti italiani, continua a offrire margini di crescita, con un potenziale di ulteriori 470 milioni di euro. Tuttavia, è importante considerare le attuali difficoltà economiche che la Germania sta attraversando, in particolare nel settore automobilistico, e che potrebbero influenzare la domanda complessiva per l’export italiano di macchinari e beni dell’ACT e, pertanto, limitare la realizzabilità del potenziale.
Anche altri mercati europei, come Francia, Austria e Spagna, mostrano opportunità significative: il potenziale di export è stimato rispettivamente in 470 milioni, 370 milioni e 300 milioni di euro. Infine, oltre al potenziale realizzabile, è fondamentale valutare anche lo spazio di manovra aggiuntivo. Quest’ultimo evidenzia come Stati Uniti, Giappone e Corea del Sud dispongano delle maggiori opportunità di crescita. La concretizzazione di queste possibilità dipende dalla capacità del Made in Italy di rafforzare ulteriormente la propria presenza in mercati consolidati, come quello statunitense, e di espandersi in mercati dove l’attuale quota di export è ancora limitata, come nel caso dei due giganti asiatici.
Il Grafico 2.2 presenta l’indice di contendibilità, una misura che esprime in termini percentuali il rapporto tra il potenziale realizzabile e l’export effettivo. Questo indicatore consente di valutare quanto margine di crescita esiste in un mercato rispetto alla presenza commerciale attuale, offrendo un’importante chiave di lettura per identificare le opportunità ancora inesplorate. Nel grafico, i mercati avanzati sono ordinati in base al loro potenziale realizzabile.

Austria, Danimarca e Corea del Sud si distinguono per i valori più alti dell’indice di contendibilità. L’Austria primeggia (63%), seguita dalla Danimarca (45,3%) e dalla Corea del Sud (44%). Questi dati indicano che in tali mercati esiste ancora un ampio margine per incrementare le esportazioni, a fronte di un potenziale non ancora pienamente sfruttato. Un indice di contendibilità elevato suggerisce, infatti, che il mercato offre significative opportunità di crescita per le imprese che desiderano aumentare la propria presenza. In questi casi, il contesto commerciale potrebbe essere caratterizzato da minori barriere all’ingresso o da una domanda insoddisfatta che può essere intercettata con strategie mirate. Al contrario, un valore più basso dell’indice potrebbe indicare mercati più maturi o difficili da penetrare, dove il margine per ulteriori espansioni è più ridotto o richiede interventi più strutturati. Questa analisi evidenzia dunque l’importanza di un approccio strategico per sfruttare al meglio le opportunità nei mercati avanzati, con particolare attenzione a quelli in cui il potenziale inespresso è ancora significativo.
I principali concorrenti dell’Italia nei mercati avanzati sono Germania e Cina. Per comprendere appieno il potenziale di export, è fondamentale analizzare la struttura dei mercati e identificare i principali concorrenti. Vengono considerati concorrenti solo quei paesi che presentano caratteristiche simili all’Italia e esportano le categorie di prodotto dell’ACT. Questo approccio consente di non stabilire a priori quali siano i concorrenti, ma di lasciare che siano i dati a definirli: la lista dei paesi concorrenti, infatti, varia in funzione di ciascun prodotto e mercato specifico.

Il Grafico 2.3 presenta dati aggregati che forniscono una visione sintetica per paese, evidenziando i principali concorrenti dell’Italia nei principali mercati avanzati e le loro quote di mercato: Germania e Cina sono appunto i concorrenti con i quali l’Italia si confronta più frequentemente nei beni dell’ACT nei mercati avanzati. La Germania, storicamente leader europeo nel settore dei macchinari, si conferma un’importante concorrente per l’Italia sia a livello europeo sia globale. Sebbene Italia e Germania siano in competizione, vi è tra esse anche una significativa interdipendenza e complementarità all’interno delle filiere globali: i due paesi si scambiano beni intermedi e una parte del valore aggiunto italiano contribuisce alle esportazioni tedesche nel mondo (e viceversa, seppur in misura minore).
La Cina, invece, rappresenta il secondo concorrente principale a livello mondiale, con una presenza competitiva in sedici dei venti mercati avanzati a maggior potenziale per l’export italiano.
Negli Stati Uniti, la Germania, insieme a Cina e Giappone, è tra i maggiori concorrenti dell’Italia, con una quota di mercato superiore a quella italiana. La vicinanza geografica tra Italia e Germania e la somiglianza nelle specializzazioni settoriali ne accentuano la competizione.
Sempre la vicinanza geografica, in questo caso tra paese esportatore e mercato di destinazione, rende prevedibile la presenza del Giappone e della Spagna tra i principali concorrenti dell’Italia, rispettivamente nei mercati della Corea del Sud e del Portogallo. Gli Stati Uniti, per ragioni geografiche, sono attivi come concorrente in Canada, assumendo una posizione di leadership nel paese nordamericano. Infine, in Germania, che è anche un grande mercato di import nonché destinazione rilevante per l’export italiano, è la Cina a rappresentare il principale competitor dell’Italia.
La Germania occupa posizioni di rilievo nei mercati dei prodotti dell’ACT, con quote di mercato elevate che si sovrappongono in misura significativa a quelle italiane. Al di là dei valori aggregati, è necessario approfondire l’analisi a livello di prodotto e a parità di caratteristiche rilevanti in modo da valutare anche l’effettivo grado di concorrenza e il livello di sovrapposizione tra l’export italiano e quello dei paesi concorrenti. Infatti, il grado di competizione tra i diversi concorrenti dell’Italia varia poiché i beni esportati e le caratteristiche dei paesi esportatori differiscono; per esempio, differenze molto significative nei prezzi o nelle tipologie di prodotti esportati rendono meno diretta la competizione. Per misurare il grado di concorrenza diretta, si analizza la quota di export italiano esposta alla competizione di un determinato paese rivale in ciascun mercato. I risultati di questa analisi sono riportati nel Grafico 2.4. Tra i principali competitor, la Germania si distingue non solo per quote di mercato rilevanti, spesso superiori a quelle italiane (Grafico 2.3), ma anche per una notevole sovrapposizione nei prodotti esportati (Grafico 2.4).
Negli Stati Uniti, oltre alla Germania, anche il Giappone e la Cina rappresentano concorrenti significativi per l’Italia. In particolare, oltre il 23% dell’export italiano verso gli USA risulta in diretta sovrapposizione con quello tedesco e giapponese. Al contrario, la sovrapposizione tra l’export cinese e quello italiano è più contenuta, pari a circa l’8%.


Nei principali mercati avanzati, ordinati in base al potenziale realizzabile, la Germania come concorrente evidenzia la più alta sovrapposizione nei prodotti esportati in Austria e Svizzera, raggiungendo picchi del 59,3%. Tuttavia, quando si considera la Germania come mercato di riferimento, la maggiore sovrapposizione si registra con la Cina, con un valore significativo pari al 14,4%. Questi dati sottolineano la forte interconnessione commerciale tra economie geograficamente e culturalmente vicine, come Germania, Austria e Svizzera, ma evidenziano anche l’importanza della Cina come concorrente su scala globale, con una presenza rilevante anche in un mercato avanzato come quello tedesco.
Tra le caratteristiche considerate per analizzare la sovrapposizione con l’export dei concorrenti, il prezzo è una delle più indicative in quanto sintetizza informazioni sui costi e sulla qualità dei prodotti. Queste ovviamente possono cambiare in base ai prodotti specifici e ai mercati, ma è tuttavia utile guardare il quadro d’insieme nel confronto tra l’Italia e i suoi concorrenti per comprendere il posizionamento medio e aumentare il dettaglio circa il grado di concorrenza. I prezzi italiani del settore ACT tendono a essere, in media, abbastanza allineati con quelli dei principali competitor nei mercati avanzati, con alcune eccezioni, tra cui la Cina che esporta a prezzi decisamente inferiori. Il Grafico 2.5 illustra il posizionamento di prezzo dell’export italiano rispetto ai principali concorrenti nei primi dieci mercati avanzati (prezzo medio dell’Italia diviso prezzo medio dei concorrenti), ordinati per potenziale sfruttabile. Si osserva che i prezzi italiani sono mediamente abbastanza allineati a quelli dei concorrenti, specialmente quelli provenienti dai mercati avanzati, tra cui la Germania. Al contrario, i prezzi medi dell’Italia sono ben più elevati rispetto a quelli di alcuni competitor provenienti dai paesi emergenti, in particolare la Cina, con la quale la differenza di prezzo è significativa. Sebbene ciò possa rappresentare una sfida competitiva, soprattutto verso concorrenti che operano su segmenti a basso costo, il dato evidenzia anche la capacità del settore ACT italiano di esportare principalmente prodotti di fascia medio-alta.
Considerato che competere con la Cina in termini di economie di scala risulta complesso, la strategia preferita dal settore ACT italiano sembra essere quella di puntare sempre di più sulla qualità, sulla differenziazione e personalizzazione del prodotto, mantenendo un posizionamento distintivo nei mercati avanzati.

Il settore con il più alto potenziale di crescita in valore è quello dei Sistemi e componenti meccatronici per la trasmissione di potenza. Il Grafico 2.6 evidenzia i potenziali di export nei mercati avanzati, suddivisi per settore. In cima alla classifica si posizionano i sistemi e componenti meccatronici per la trasmissione di potenza, con un potenziale aggiuntivo stimato di 1,69 miliardi di euro. Seguono le macchine utensili, robot e automazione, con un potenziale di 690 milioni di euro, e le macchine e stampi per materie plastiche e gomma, che raggiungono i 630 milioni di euro. Anche altri settori si distinguono per opportunità significative, come le macchine per confezionamento e imballaggio (400 milioni di euro) e le macchine per la lavorazione del legno (390 milioni di euro). Concentrandosi sullo spazio di manovra aggiuntivo, i maggiori margini di crescita per l’export si confermano nei settori dei sistemi e componenti meccatronici per la trasmissione di potenza, delle macchine utensili, robot e automazione e delle macchine e stampi per materie plastiche e gomma. Questi dati evidenziano settori chiave dove il Made in Italy può ulteriormente rafforzare la propria presenza, consolidando la competitività sui mercati internazionali.
L’analisi precedente ha mostrato che i principali mercati avanzati con maggior potenziale per l’export italiano sono Stati Uniti, Germania e Francia. In tutti i settori ACT, gli Stati Uniti emergono come un mercato chiave (Grafico 2.7), con un potenziale di 235 milioni di euro per i Sistemi e componenti meccatronici per la trasmissione di potenza, 134 milioni per Macchine e stampi per materie plastiche e gomma e 122 milioni per Macchine utensili, robot e automazione. Nel settore dei Sistemi e componenti meccatronici per la trasmissione di potenza, i mercati più promettenti sono Francia (244 milioni di euro), Stati Uniti (235 milioni) e Austria (173 milioni).
L’Austria mostra indici di contendibilità elevati nei Sistemi e componenti meccatronici per la trasmissione di potenza e Macchine utensili, robot e automazione. L’Austria si conferma un mercato avanzato con indici di contendibilità estremamente elevati, evidenziando significative opportunità di crescita per le esportazioni italiane. Questo indice, definito come il rapporto tra il potenziale realizzabile e l’export effettivo, mostra chiaramente quanto margine di mercato sia ancora disponibile. Nel settore dei sistemi e componenti meccatronici per la trasmissione di potenza, l’Austria presenta un indice di contendibilità pari al 73%. Ancora più significativo è il dato relativo al settore delle macchine utensili, robot e automazione, dove l’indice raggiunge l’89%. Questi risultati sottolineano come l’Austria rappresenti un mercato particolarmente ricettivo per i settori ad alto contenuto tecnologico, dove il Made in Italy può fare leva sulla propria eccellenza industriale per guadagnare quote di mercato. L’elevata contendibilità evidenzia un contesto competitivo favorevole, con barriere all’ingresso relativamente basse e una domanda orientata verso prodotti di qualità. Per le imprese italiane, questo si traduce in un’opportunità concreta di consolidare la propria presenza attraverso strategie mirate, come l’innovazione tecnologica, la personalizzazione dell’offerta e il rafforzamento dei servizi post-vendita. L’Austria, dunque, non è solo un partner commerciale strategico, ma un mercato ideale per valorizzare le eccellenze italiane in settori tecnologicamente avanzati.

Negli ultimi tre anni, molti comparti hanno registrato una perdita di posizioni per l’Italia, evidenziata da una riduzione delle quote di mercato e indicativa delle difficoltà incontrate dagli operatori nel valorizzare appieno il potenziale disponibile. In controtendenza, un settore ha invece mostrato un miglioramento generale delle posizioni italiane: Sistemi e componenti meccatronici per la trasmissione di potenza.
Il settore dei Sistemi e componenti meccatronici per la trasmissione di potenza presenta un eccellente posizionamento per l’industria italiana in Francia. In questo ambito, le imprese italiane non solo hanno registrato variazioni percentuali positive delle quote di mercato in tutti e tre i principali mercati, ma si distinguono in particolare per un incremento significativo in Francia, dove la quota italiana si attesta al 12,2%. Questo risultato sottolinea la competitività delle aziende italiane e il loro successo nell’espandere la propria presenza nel mercato francese.
Le imprese italiane vantano un posizionamento di eccellenza nel settore delle Macchine per calzature, pelletteria e conceria, soprattutto in Austria. In questo comparto, il potenziale di crescita in valore risulta limitato, poiché l’Italia è già leader in numerosi prodotti, con quote di mercato elevate e spesso in espansione. Questo successo riflette una performance consolidata e altamente competitiva rispetto agli altri operatori internazionali. Dunque, il livello attuale conferma la forte competitività delle imprese italiane nel settore.
Il potenziale realizzabile nei mercati emergenti è significativo, sebbene la loro dimensione complessiva sia relativamente contenuta. L’export italiano di prodotti ACT (Automazione, Componentistica e Tecnologia) verso i mercati emergenti risulta strutturalmente inferiore rispetto ai mercati avanzati. Questo divario è in parte fisiologico, poiché i paesi avanzati dispongono di mercati economicamente più ampi, ma riflette anche una presenza limitata degli esportatori italiani in queste aree. Tuttavia, i mercati emergenti presentano un forte interesse per il settore ACT, poiché in molti di essi si concentrano ormai importanti attività manifatturiere, anche a elevato contenuto tecnologico, che richiedono macchinari e attrezzature avanzate. Nel Grafico 2.8, si evidenziano l’export effettivo, il potenziale realizzabile e lo spazio di manovra aggiuntivo dell’Italia nei principali mercati emergenti, ordinati per potenziale realizzabile in miliardi di euro, per mettere in risalto i mercati che presentano le maggiori opportunità di vendita.
Primato della Cina sia per i valori dell’export effettivo che per il potenziale realizzabile. L’analisi di questi mercati, illustrata nel Grafico 2.8, evidenzia il primato della Cina sia per i valori dell’export effettivo che per il potenziale realizzabile, stimato in 760 milioni di euro. Pur non raggiungendo ancora le dimensioni del mercato statunitense per l’export italiano, la Cina rappresenta una fonte aggiuntiva di opportunità, nonché un mercato strategico per l’Italia al fine di incrementare la propria presenza nel mondo. Tra i mercati emergenti con maggior potenziale, spiccano India, Turchia e Messico con un export realizzabile stimato rispettivamente a 470 milioni, 360 milioni e 280 milioni di euro. Seguono Algeria e Brasile, con un potenziale rispettivamente pari a 280 milioni di euro e 210 milioni di euro.

Il Grafico 2.9 presenta l’indice di contendibilità, una misura che esprime in termini percentuali il rapporto tra il potenziale realizzabile e l’export effettivo. Nel grafico, i mercati emergenti sono ordinati in base al loro potenziale realizzabile.
L’Algeria presenta un indice di contendibilità pari al 94%. Dal Grafico 2.9 è possibile osservare come l’Algeria abbia un indice di contendibilità particolarmente elevato, indicando la possibilità di incrementare l’export in questo paese data l’alta competitività del made in Italy. A seguire, la Malesia, il Vietnam e la Tailandia, presentano indici di contendibilità rispettivamente pari al 56,2%, 54,4% e 51,9%.
La Turchia, secondo mercato emergente per l’export italiano, mostra un indice di contendibilità sensibilmente inferiore rispetto a Cina e India. La Turchia, pur essendo il secondo mercato emergente per l’export italiano, registra un indice di contendibilità relativamente basso, pari al 24,1%. Questo valore è sensibilmente inferiore rispetto a quello della Cina (43%) e dell’India (43,9%), riflettendo un posizionamento dell’Italia già piuttosto consolidato nel mercato turco. Tuttavia, l’analisi evidenzia la necessità di implementare strategie mirate per sfruttare appieno il potenziale ancora realizzabile, specialmente in settori chiave dove la domanda locale potrebbe crescere.
Un aspetto interessante è che, in generale, i mercati emergenti mostrano indici di contendibilità strutturalmente più elevati rispetto a quelli dei mercati avanzati. Questo dato indica che, nonostante alcune aree siano già ben presidiate, esistono margini di crescita significativi. Con un approccio strategico e investimenti mirati, l’Italia potrebbe rafforzare ulteriormente la propria presenza nei mercati emergenti, capitalizzando sul loro dinamismo e sulle prospettive di sviluppo a medio-lungo termine.

Nei mercati emergenti, la Cina si conferma come il principale concorrente dell’Italia nelle categorie merceologiche dei prodotti ACT, seguita da Germania e Giappone. Il Grafico 2.10 approfondisce il quadro per quanto riguarda le quote di mercato dell’export italiano e dei suoi principali concorrenti nelle economie emergenti. Si evidenzia come le quote di mercato dell’Italia siano ancora generalmente limitate, mentre alcuni dei concorrenti, la Germania in particolare, ottengono risultati migliori in termini di quote di mercato.
Va, tuttavia, considerato che le economie emergenti presentano dinamiche di crescita più rapide rispetto ai mercati maturi avanzati, e in contesti molto dinamici come quelli emergenti si presentano spesso nuove opportunità. Per l’Italia, intercettare queste opportunità richiede una strategia mirata, soprattutto nei mercati asiatici, caratterizzati da una domanda in rapida evoluzione.
Risultati negativi per l’export italiano nella maggior parte dei mercati emergenti Al momento, l’export italiano non sembra cogliere le opportunità nei mercati emergenti, e al contrario le vendite in molti di questi mercati segnano una leggera flessione. La scarsa performance dell’ultimo triennio rende ancora più urgente per gli imprenditori comprendere e attivare le leve giuste per espandersi. Essere presenti sul territorio diventa fondamentale per anticipare tendenze, adattarsi alle specificità della domanda locale e ridurre le distanze logistico-commerciali tra fornitori e clienti. È cruciale, altresì, monitorare costantemente i cambiamenti normativi e le politiche amministrative locali.
Infine, strategie di marketing, comunicazione e pricing adeguate sono altrettanto essenziali per rafforzare la competitività dell’Italia nei mercati emergenti e cogliere le opportunità che questi offrono. Sebbene il confronto tra le quote di mercato possa fornire una stima del potenziale di export per le categorie di prodotti dell’ACT, non sempre riesce a catturare il livello di concorrenza diretta tra i diversi competitor. Per ottenere una visione più precisa, il Grafico 2.11 illustra la quota di export italiano effettivamente in competizione diretta con i prodotti esportati dai concorrenti nei mercati emergenti.

I principali concorrenti dell’Italia nei mercati emergenti sono la Germania e la Cina, entrambi caratterizzati da un alto grado di sovrapposizione con l’export italiano. Nei mercati emergenti, così come in quelli avanzati, la concorrenza della Germania continua a essere pressante: questo Paese emerge ancora una volta come il principale competitor in quasi tutti i mercati, con una significativa sovrapposizione rispetto all’export italiano di prodotti dell’ACT. Anche la Cina esercita una pressione competitiva importante, con un grado di sovrapposizione con i prodotti italiani abbastanza elevato. Questo evidenzia non solo il crescente peso quantitativo della Cina nell’export globale, ma anche come la competizione proveniente dalla Cina stia diventando sempre più intensa proprio all’interno delle stesse categorie merceologiche esportate dall’Italia. Un’eccezione a questa dinamica si trova in Algeria, dove la sovrapposizione più elevata non riguarda né la Germania né la Cina, ma i prodotti francesi, che risultano in diretta sovrapposizione con l’13,7% dell’export italiano. In questo mercato, la Francia si configura come il principale concorrente dell’Italia, seppur con un grado di sovrapposizione non particolarmente elevato. Il Giappone, pur non essendo in nessuno dei paesi considerati il competitor principale, presenta una sovrapposizione importante in paesi quali Cina e Vietnam, con una quota pari rispettivamente al 23,4% e 24,3%.
In generale, per gli esportatori italiani, la chiave per migliorare le performance nei mercati emergenti – soprattutto in quelli dove la Cina è il principale concorrente – più che in una strenua guerra di prezzo, sembra risiedere nella capacità di differenziarsi puntando sulla qualità dei prodotti e dei servizi offerti.
I prezzi italiani del settore ACT nei mercati emergenti tendono a essere, in media, allineati a quelli dei competitor avanzati, ma molto superiori rispetto a quelli dei principali competitor emergenti. Il Grafico 2.12 illustra il posizionamento di prezzo dell’export italiano rispetto ai principali concorrenti nei primi dieci mercati emergenti (prezzo medio dell’Italia diviso prezzo medio dei concorrenti), ordinati per potenziale realizzabile. Come già osservato nei mercati avanzati, i prezzi italiani risultano mediamente allineati a quelli dei competitor provenienti dai mercati avanzati, come la Germania, ma ben più alti rispetto a quelli dei competitor provenienti dai paesi emergenti; in particolare, rispetto alla Cina l’Italia esporta a prezzi medi da 2 a 4 volte superiori. La sfida competitiva è evidente, soprattutto per quanto riguarda i segmenti a basso costo; tuttavia, considerata l’elevata somiglianza di prezzo rispetto a paesi come Germania e Giappone, si evidenzia anche la capacità del settore ACT italiano di collocarsi principalmente in un segmento di mercato medio-alto.

Nei mercati emergenti, i comparti con il maggiore potenziale di crescita per l’export italiano includono le Macchine e stampi per materie plastiche e gomma, i Sistemi e componenti meccatronici per la trasmissione di potenza e le Macchine per l’industria tessile. Il Grafico 2.13 presenta i risultati dell’analisi per ciascun settore, evidenziando che il potenziale di export più elevato si registra nel comparto delle macchine e stampi per materie plastiche e gomma, con un valore aggiuntivo stimato di 650 milioni di euro. Seguono i sistemi e componenti meccatronici per la trasmissione di potenza, con 640 milioni di euro, e le macchine per l’industria tessile, con 600 milioni di euro. Altri settori con potenziali significativi in termini assoluti sono le macchine utensili, robot e automazione (470 milioni di euro) e le macchine e accessori per il vetro (400 milioni di euro).
In generale, i mercati emergenti offrono spazi di manovra aggiuntivi più ampi rispetto ai mercati avanzati, riflettendo non solo il loro dinamismo economico, ma anche una minore capacità di presidio commerciale da parte delle imprese italiane. Questo dato sottolinea la necessità di strategie dedicate per rafforzare la presenza del made in Italy in questi mercati, dove la domanda è in crescita e le opportunità sono ancora largamente inesplorate.

Il Grafico 2.14 sintetizza i risultati principali dell’analisi incrociata tra settori e mercati emergenti, evidenziando Sistemi e componenti meccatronici per la trasmissione di potenza e Macchine per l’industria tessile come i comparti a maggiore potenziale. In particolare, per i Sistemi e componenti meccatronici, la Cina mostra un export potenziale di circa 178 milioni di euro, con un indice di contendibilità pari al 42%, con una quota italiana in aumento.
India e Cina si confermano tra i principali mercati per diversi comparti. L’India rappresenta il mercato maggiormente presente per i diversi comparti ACT, sebbene rappresenti il mercato prioritario soltanto per Macchine e attrezzature per ceramica e Macchine e attrezzature per la lavorazione delle pietre naturali. La Cina, invece, si distingue come mercato prioritario per quasi tutti i comparti ACT, con l’eccezione di Macchine per calzature, pelletteria e conceria, Macchine e attrezzature per la lavorazione delle pietre naturali, Macchine e attrezzature per ceramica e Macchine e accessori per il vetro.
L’Algeria risulta il mercato principale per le Macchine e accessori per il vetro, il Vietnam per le Macchine per calzature, pelletteria e conceria. L’Algeria rappresenta il mercato principale per il comparto ACT relativo alle macchine e accessori per il vetro, con un indice di contendibilità elevatissimo (170,9%), indicando importanti opportunità di export nel paese maghrebino. Il Vietnam, invece, è il mercato principale per le macchine per calzature, pelletteria e conceria, con un indice di contendibilità pari al 62,3%, sebbene le quote siano in calo.

Nel triennio 2020-2022, l’andamento delle quote è stato tendenzialmente negativo in molti comparti. Il grafico illustra anche l’andamento delle quote di mercato italiane nell’import dei mercati emergenti. Con quote in negativo in molti comparti, il quadro risulta in linea rispetto a quanto emerso per i mercati avanzati dove si è assistito ad una diffusa perdita di quote di mercato. I dati mostrano una diminuzione di quote in diversi comparti tra il 2020 e il 2022, ad eccezione del comparto relativo alle Macchine e accessori per il vetro e Macchine per l’industria tessile, in cui si è avuto un incremento delle quote italiane per tutti i mercati principali.
Opportunità di export in sintesi
L’analisi del potenziale di export nei mercati avanzati ed emergenti ha permesso di individuare le aree in cui l’Italia può espandere la propria presenza rispetto alla domanda potenziale dei prodotti ACT tenuto conto dei concorrenti con caratteristiche simili. Un esame dettagliato per singolo paese e settore ha consentito di identificare, in ogni mercato chiave, i segmenti a maggior potenziale e i principali concorrenti, la cui offerta e caratteristiche rappresentano una sfida diretta per le quote di mercato italiane.
Il raggiungimento del potenziale di export dipende sia dalla competitività complessiva del Paese esportatore, sia dalla capacità delle imprese di cogliere le opportunità offerte dai mercati esteri. Di conseguenza, se da un lato è fondamentale identificare i settori e le aree a più alto potenziale per indirizzare gli sforzi strategici, dall’altro ciò non basta per garantire un effettivo aumento della presenza italiana all’estero. È necessario valutare attentamente, caso per caso, la facilità di accesso a ciascun mercato, nonché i rischi e le opportunità specifici dei diversi settori.
Il Grafico 2.15 fornisce una sintesi dettagliata dei principali risultati dell’analisi del potenziale di export per comparti dell’ACT, distinguendo tra mercati avanzati ed emergenti. Per ciascun comparto, vengono evidenziati diversi parametri chiave: il potenziale realizzabile, lo spazio di manovra aggiuntivo e l’indice di contendibilità, analizzati separatamente per i mercati avanzati e per quelli emergenti. Questo approccio consente di valutare con maggiore precisione le opportunità di crescita in ciascuna categoria di mercato. Inoltre, il grafico include anche una panoramica globale, che aggrega i dati ottenuti dai mercati avanzati e emergenti, offrendo una visione complessiva del potenziale di export a livello mondiale.

Opportunità di export: valutare le capacità e il potenziale realizzabile. Per concretizzare le opportunità di export a livello di mercato, alla misurazione dell’indice di contendibilità vengono affiancati due indicatori sintetici a livello di paese. Il primo indicatore misura la compatibilità tra la struttura delle esportazioni italiane e la domanda di importazione dei mercati target, valutando quanto siano complementari i due paesi come partner commerciali. Questa compatibilità è alta quando la composizione delle esportazioni italiane rispecchia in gran parte la struttura della domanda di importazione del mercato di destinazione.
Il secondo indicatore, invece, valuta le prospettive di espansione, dando maggiore peso ai mercati di grande dimensione e in rapida crescita, così da orientare le imprese verso contesti in cui il potenziale di sviluppo risulta particolarmente promettente.

Compatibilità elevata con i mercati avanzati. Nei mercati avanzati, l’Italia gode di una posizione consolidata e presenta un margine di crescita relativamente contenuto; tuttavia, le grandi dimensioni e l’aumento della domanda possono offrire ulteriori opportunità di espansione dell’export. Come illustrato nel Grafico 2.16, questi mercati, caratterizzati da ampie dimensioni economiche e da una crescita del PIL in valore (rappresentata dalla grandezza delle bolle), mostrano un’elevata compatibilità con la struttura dell’export italiano. Ciò è dovuto alla domanda di beni che l’Italia è ben attrezzata a fornire. Tuttavia, trattandosi di mercati maturi, in cui l’Italia è storicamente presente, l’indice di contendibilità rimane relativamente ridotto.
Compatibilità inferiore nei mercati emergenti. Nei mercati emergenti, molti paesi mostrano dimensioni economiche più contenute e una minore compatibilità con l’export italiano. Tuttavia, in questi mercati, l’Italia dispone di un elevato indice di contendibilità, che segnala opportunità significative di aumento dell’export.
Alto indice di contendibilità nei mercati emergenti, maggiore compatibilità nei mercati avanzati. I mercati avanzati si distinguono per una maggiore compatibilità tra la loro domanda e l’offerta dell’export italiano, grazie a una domanda strutturata e affine ai prodotti italiani. Tuttavia, presentano un indice di contendibilità più basso, dovuto alla forte presenza di competitor consolidati. Al contrario, i mercati emergenti offrono spesso un alto indice di contendibilità, ma con una compatibilità più limitata rispetto ai mercati avanzati, segnando opportunità meno immediate ma comunque rilevanti.
In Asia, la Cina rappresenta un mercato enorme e in rapida espansione. Nonostante ciò, la compatibilità con l’export italiano resta relativamente bassa, probabilmente perché la domanda di prodotti ACT è già ampiamente soddisfatta da competitor locali, come le aziende cinesi, e da produttori internazionali, tra cui Germania, Giappone e Corea del Sud. L’India, invece, mostra un alto indice di contendibilità associato a una compatibilità più elevata rispetto ad altri mercati emergenti. Questo rende il paese un’opportunità interessante per sviluppare ulteriormente le relazioni commerciali nel settore ACT.
Anche in altri mercati asiatici, la dinamica è simile: paesi avanzati come Giappone e Corea del Sud presentano indici di contendibilità elevati, ma con una compatibilità inferiore rispetto ai principali mercati avanzati. Mercati emergenti come Thailandia e Indonesia offrono invece una contendibilità elevata, sebbene con una compatibilità domanda-offerta inferiore rispetto a quella riscontrabile in India o nei paesi avanzati. Il Vietnam, invece, ricopre una posizione intermedia con un alto indice di contendibilità e una compatibilità simile a quella dell’India.
Turchia ed Emirati Arabi Uniti: compatibilità elevata nei mercati emergenti. A differenza della maggior parte dei mercati emergenti, Turchia ed Emirati Arabi Uniti si distinguono per un’elevata compatibilità con l’export italiano, grazie alla convergenza tra domanda locale e offerta di prodotti italiani. Tuttavia, questi mercati mostrano un indice di contendibilità relativamente basso, in linea con i principali mercati avanzati, indicando una concorrenza ben strutturata e consolidata.

Elevati investimenti fissi combinati con elevati indici di contendibilità nei mercati emergenti. Il Grafico 2.17 evidenzia la relazione tra l’indice di contendibilità in ogni paese, sia avanzato che emergente, e il tasso di crescita degli investimenti fissi, offrendo importanti spunti strategici per il settore ACT. I mercati emergenti, in particolare, si distinguono per la combinazione di un indice di contendibilità strutturalmente più alto e tassi di crescita degli investimenti fissi particolarmente dinamici. Tra questi, l’India emerge come un mercato prioritario, grazie alle ampie dimensioni e alle significative opportunità per il futuro dell’export ACT.
Principali opportunità di export: Austria, Stati Uniti e Danimarca tra i mercati avanzati; Cina, Algeria e India tra gli emergenti. Il Grafico 2.18 presenta un indice sintetico che integra l’indice di contendibilità, la compatibilità tra domanda e offerta, e le prospettive di crescita del mercato, fornendo una panoramica delle migliori opportunità di export. Tra i mercati avanzati, Austria, Stati Uniti e Danimarca emergono come quelli con le maggiori potenzialità di crescita per l’export italiano. Nei mercati emergenti, le principali opportunità si concentrano in Cina, Algeria e India.
Stati Uniti e Cina si confermano mercati di importanza strategica, grazie non solo al significativo potenziale realizzabile rispetto ai concorrenti, ma anche alla dimensione dei mercati e alle prospettive di espansione della domanda. L’India, sebbene si collochi in una posizione intermedia, rappresenta un’economia emergente promettente, da monitorare attentamente per le sue prospettive di crescita.
Austria e Danimarca, così come Algeria e Vietnam, offrono opportunità interessanti nonostante non siano mercati di grandi dimensioni. In questi casi, il bilanciamento positivo tra compatibilità domanda-offerta e indice di contendibilità indica che le imprese italiane hanno le caratteristiche necessarie per rafforzare la propria competitività e cogliere nuove opportunità di sviluppo.

L’intelligenza artificiale (IA) non è nata oggi. Se ne parla dal 1950. Più precisamente fu Alan Turing a svolgere il primo esperimento finalizzato a comprendere se una macchina può assumere un comportamento intelligente e interagire con umani. Sono dunque passati 70 anni, tra alti e bassi, senza che il tema dell’IA entrasse veramente al centro del dibattito mainstream. Da novembre 2022 tutto è cambiato: il lancio presso il pubblico di ChatGPT ha reso questa tecnologia quasi un fenomeno cult. Se ne parla in ogni dove, si discute del ruolo che l’intelligenza artificiale generativa potrà avere nel futuro prossimo e, soprattutto, se e in che misura potrà sostituire l’essere umano. Occorre fin da subito sgomberare il campo da equivoci: l’IA è ormai un fattore strutturale del nostro sistema socio-tecnico: sarà in grado di ridurre le disuguaglianze (di natura cognitiva) in quanto fondata sul linguaggio e quindi contraddistinta da una facilità d’uso senza eguali. Tornare indietro è impossibile. Dovremo abituarci a considerare l’adozione dell’IA alla stregua dell’introduzione dell’energia elettrica: a rappresentarne, da un lato, l’impatto pervasivo e, dall’altro, il potenziale effetto trasformativo nelle dinamiche di funzionamento di persone, imprese e oggetti. L’intelligenza artificiale generativa, ovvero la tecnologia in grado di produrre testo, immagini e altri linguaggi, impatterà infatti in misura significativa nella vita delle persone del XXI secolo. Sarà molto più dirompente della stampa. La capacità dell’IA generativa di digerire quasi l’intera portata della conoscenza umana, addestrando algoritmi di modelli linguistici di grandi dimensioni con centinaia di miliardi di parametri, le consente di scrivere, disegnare, ragionare e risolvere problemi. La stampa ha accelerato la diffusione della conoscenza. L’IA generativa accelererà la creazione di conoscenza. Come emergerà più avanti nel corso di questa riflessione, l’IA generativa migliorerà la produttività e genererà un valore economico assolutamente significativo. È del tutto probabile che l’IA rappresenterà la leva di cambiamento più rilevante nella storia industriale moderna.
Che cosa è l’IA. Vi è non poca confusione su che cosa sia effettivamente l’IA e questa confusione rappresenta una delle cause che induce distorsioni nel dibattito attuale. Occorre in primo luogo partire dalla stessa locuzione semantica “Intelligenza Artificiale”: non vi è dubbio che questa rappresenti il miglior modo per indurre molti di noi in errore. Come sottolinea Maurizio Ferraris in un suo recente articolo al Corriere della Sera, abbiamo a che fare con un’espressione che viene adottata “in mancanza di meglio e sulla base di una vaga somiglianza, come quando si parla di «gamba di una sedia» o di «collo di bottiglia». Ovviamente le sedie non hanno “gambe” né le bottiglie “colli”, ma sono espressioni che ricordano entità del mondo reale attraverso immagini, pur restandone distinte e differenti. Dice Ferraris che dovremmo vedere l’IA “non come la sorella meccanica di una facoltà che noi possediamo in forma organica, quanto una sconfinata biblioteca di Babele che può interagire con l’intelligenza naturale”. L’IA deve essere quindi intesa come strumento a supporto delle attività dell’uomo. Uno strumento che ha una capacità di apprendimento molto spiccata (grazia alla sua potenza computazionale) è in grado di tradurre questo apprendimento in azioni automatiche (fondate sull’analisi dei dati) che possono riguardare decisioni e/o vere e proprie attività riconducibili alla sfera del codificato. È molto diversa da un algoritmo informatico standard, questo contiene infatti un set specifico di istruzioni di programmazione che dicono al sistema esattamente cosa fare e in quale ordine. Un algoritmo IA, invece, è progettato per imparare il modo migliore per eseguire un’attività senza usare istruzioni specifiche. Sia chiaro: azioni e automazioni sono sempre la conseguenza di un'interpretazione correlativa e associativa dei dati, sono ovvero il frutto di una visione del futuro ricorrente/coerente con gli schemi interpretativi che l’IA ha appreso con le basi dati del passato. L’IA in altre parole non è in grado di introdurre discontinuità logiche, ovvero quei “salti di significato” che sono tipici del genere umano e che continueranno a qualificarlo in misura del tutto distintiva. In sostanza, l’intelligenza umana e l’IA presentano (per fortuna) notevoli differenze: la prima è intrinsecamente legata alla nostra natura di persone, di esseri viventi e senzienti, la nostra umanità. La seconda, invece, non è assimilabile alla precedente, poiché priva di coscienza di sé; essa si distingue per una funzione meramente esecutiva, agendo come un sistema automatico che esegue azioni in stretta coerenza con ciò che ha appreso.
La (nuova) primavera dell’IA: tra speranze e timori. Se per 70 anni l’IA è passata sottotraccia, come si spiega la sua rilevanza oggi? Tre sono le determinanti che rispondono a questa domanda e, in un certo qual modo, ne motivano l’ineluttabilità ai giorni nostri. La crescente disponibilità di dati unita alla continua evoluzione della potenza di calcolo, rappresentano sicuramente fattori determinanti in grado di qualificare una vera discontinuità (rispetto al recente passato) nel potenziale insito nell’IA. Se a questi fattori uniamo la facilità con cui è ormai possibile interagire con sistemi che utilizzano questa tecnologia (ad esempio, attraverso la voce) comprendiamo quanto pervasivo possa essere l’impatto dell’IA nella vita delle persone, delle imprese e delle istituzioni pubbliche.
L’IA di ultima generazione ha ormai un impatto pervasivo. Se nel passato potevano essere affidati a questa tecnologia compiti specializzati, quali la traduzione di una lingua straniera o l’interazione via chatbot con un consumatore alla ricerca della risoluzione ad un problema ben definito, oggi lo spettro dei temi e delle azioni attivabili con l’IA è molto più ampio. Si inseriscono in questo contesto le differenti prospettive sul ruolo dell’IA che si vanno affermando a livello internazionale e che la recente vicenda della cacciata con successivo reintegro in OpenAI di Sam Altman ha, se possibile, rafforzato. Da una parte, abbiamo coloro – non pochi scienziati esperti del tema, i cosiddetti doomers – che attribuiscono all’IA una minaccia di natura esistenziale per il genere umano. Sono i cosiddetti tecno-apocalittici, secondo cui lo sviluppo dell’IA porterà inevitabilmente a una super intelligenza, che a sua volta potrebbe sfuggire al controllo dell’essere umano e ribellarsi a esso. È la visione che ha portato il premier britannico Sunak ad organizzare a Londra nel 2023 un summit specificamente rivolto a capire quale governance abbia senso per la gestione del “rischio IA”.
Dall’altra parte, in una logica polare, vi sono i tecno-utopisti, che vedono nella tecnologia una importante (e forse determinante) occasione per migliorare le dinamiche di funzionamento dei sistemi sociali e di interazione dei soggetti economici. Gli utopisti sono contrari a qualsiasi regolamentazione che possa rallentarne lo sviluppo e, anzi, puntano a massimizzare il potenziale dell’IA nei tempi più̀ rapidi possibili. Ovviamente, anche il gruppo dei tecno-ottimisti – al quale possiamo ascrivere il fondatore di OpenAI Sam Altman – presta attenzione ai potenziali rischi. E, ovviamente, anch’essi condividono l’idea che l’IA forte potrebbe sorgere nel giro di pochi anni. Ciò che li contraddistingue è la fiducia nei confronti di una tecnologia che, se sviluppata nel modo giusto, porterà il mondo a vivere una nuova utopia socioeconomica.
Al netto di queste polarità è opportuno tenere conto che la storia ci può essere d’aiuto per meglio comprendere che cosa potrebbe/dovrebbe accadere nel percorso di sviluppo dell’IA. In particolare, la prima lezione che possiamo trarre dal passato è che le più rilevanti innovazioni tecnologiche hanno manifestato il loro impatto positivo a livello economico non tanto nel breve, quanto piuttosto in un orizzonte di medio-lungo periodo. James Watt ha, ad esempio, brevettato l’invenzione del motore a vapore nel 1769 ma solo dopo il 1830
Ha cominciato a impattare sui sistemi produttivi e addirittura dopo il 1850 a presentare effetti significativi sulla produttività. Nel caso dei circuiti integrati di silicio non sono bastati tre decenni per conseguire un impatto rilevante sulle statistiche di produttività. Soltanto nel 1990 – con l’avvento del personal computer – si è innescata una traiettoria fortemente positiva attivata dalla nuova tecnologia. Il gap temporale rilevato tra l’innovazione e i relativi effetti economici è in parte conseguente alla necessità di far evolvere la tecnologia. I primi motori a vapore erano largamente inefficienti e consumavano una quantità eccessiva di carbone, così come si verifica oggi per le applicazioni di IA. Con riferimento all’IA, dobbiamo tenere conto che la scala dei tempi è per certi versi mutata; operiamo in un contesto in cui tutto è accelerato in cui i tempi di diffusione di una (nuova) tecnologia sono inevitabilmente molto più rapidi. Vi sono, d’altro canto, studi scientifici che evidenziano come l’introduzione di una disruption tecnologica inneschi una curva di produttività a forma di J: nei primi anni/decenni dell’innovazione, l’andamento della produttività peggiora a causa dei (necessari) meccanismi di apprendimento della stessa e della opportunità di disegnare nuovi processi intorno ad essa. Nel caso dell’IA, già presente nel sistema socio-tecnico negli anni ’70, siamo ormai prossimi alla fase verticale della J: in altre parole, l’IA manifesterà molto presto i suoi effetti. Una seconda lezione di ordine storico riguarda il potenziale effetto sostitutivo dell’IA rispetto al lavoro umano. L’analisi di innovazioni di portata similare ha evidenziato che non si sono mai riscontrati peggioramenti negli indici di occupazione delle persone. In particolare, l’avvento del motore a vapore e l’arrivo dell’elettrificazione hanno determinato invece ripercussioni economiche molto positive. Questo ovviamente non significa che non sia opportuno e necessario affrontare con grande attenzione le sfide che l’IA pone; è importante andare oltre i pregiudizi e comprendere l’impatto che questa tecnologia può avere nel sistema socio-economico.
IA e società: una vista integrata del suo impatto. Il ruolo profondamente trasformativo dell’IA richiede un'attenta analisi del suo impatto secondo una prospettiva sistemica. In termini qualitativi, è del tutto evidente che la sua diffusione modificherà modelli di business delle imprese, impatterà sulle logiche con cui sono costruite le catene del valore, determinerà un nuovo corso nella gestione dei processi decisionali, richiederà una revisione dei processi educativi e modificherà il contenuto del lavoro e delle mansioni che gli individui porteranno avanti. È proprio a partire da questa prospettiva che si comprende perché l’IA stia diventando un tema chiave nelle relazioni geopolitiche tra Stati: tanto che nel recente incontro – a margine della Conferenza APAX di San Francisco - tra il Presidente Biden e Xi Jinping si è decisa l’opportunità di avviare un tavolo negoziale specificamente volto a disciplinare l’utilizzo dell’IA a fini militari. Occorre, in particolare, considerare che gli USA hanno sostenuto la propria leadership a livello internazionale, nel post Seconda Guerra Mondiale, grazie al possesso di tecnologie distintive ma, come è evidente, la tecnologia non è un qualcosa di statico ed evolve molto rapidamente. Nel caso specifico, occorre tenere presente che, così come agli albori della rivoluzione industriale vennero progettate macchine in grado di garantire prestazioni funzionali superiori rispetto al coinvolgimento umano, la rivoluzione dell’IA sta portando le macchine ad avere capacità cognitive che, per task codificati, sono già oggi comparabili con quelle umane. È su questa pista che si confronteranno le due super potenze ed è sulla capacità di sviluppo di ecosistemi orientati al potenziamento e alla diffusione dell’IA che si giocheranno i futuri assetti negoziali nei tavoli multilaterali tra Stati; in questo, la speranza è che l’Europa possa ritagliarsi un ruolo onde evitare di diventare attore secondario su scala geopolitica, quando poco più di 100 anni fa (precisamente nel 1914) il Vecchio Continente controllava l’80% della superficie terrestre.
Se spostiamo il focus a livello di imprese, se ne ricava un quadro in forte evoluzione; secondo uno studio Mc Kinsey, l’adozione di soluzioni di IA è più che raddoppiata a partire dal 2017 e se ne prevede una crescita esponenziale come diretta conseguenza della maggiore accessibilità e facilità di utilizzo di Large Language Models (LLM). In particolare, come emerge dal Grafico 3.1, gli investimenti previsti in IA e machine learning raggiungeranno la ragguardevole cifra di 400 miliardi di dollari. Si tratta peraltro di un percorso di crescita disomogeneo. Ad esempio, l’Italia appare essere in significativo ritardo per due ordini di motivi. In primo luogo, gioca un ruolo importante la presenza di una cultura orientata all’eccellenza di prodotto e produzione – tratto caratteristico del Made in Italy – che si è tradotta in una oggettiva minore sensibilità sul fronte dei processi di codifica dei dati (necessari per alimentare l’addestramento di motori di IA). In secondo luogo, il nostro Paese parte da una situazione di svantaggio comparato, posizionandosi come quartultimo, nell’Europa a 27, per disponibilità di competenze digitali.

Con l’obiettivo di evidenziare le specificità e il relativo ritardo dell’Italia, si riportano nel seguito alcuni estratti del report 2023 dell’Osservatorio sull’IA della School of Management del Politecnico di Milano. Il mercato dell’IA, in Italia, cresce in misura consistente anche perché ci si muove su una scala ancora davvero minimale. Nel 2023 ha segnato +52%, raggiungendo il valore di 760 milioni di euro. Occorre tuttavia considerare che l’Europa investe il 5% degli USA in IA e l’Italia è nelle retrovie europee; il quadro è dunque sì in crescita ma partiamo da una situazione di grave ritardo. La gran parte degli investimenti riguarda soluzioni di analisi e interpretazione testi per ricerca semantica, di classificazione, sintesi e spiegazione di documenti o agenti conversazionali tradizionali, mentre sono ancora limitati al 5% (38 milioni di euro) i progetti di IA generativa. Sei grandi imprese italiane su dieci hanno già avviato un qualche progetto d’IA, almeno a livello di sperimentazione, ma ben due su tre hanno già discusso internamente delle applicazioni delle IA generative e tra queste una su quattro ha avviato una sperimentazione (il 17% del totale).
Il mercato. Il 90% del mercato dell’IA in Italia è appannaggio delle grandi imprese. La quota più significativa del mercato dell’IA italiano (29%) è legata a soluzioni per analizzare ed estrarre informazioni dai dati (Data Exploration & Prediction, Decision Support & Optimization Systems). Il 27% è per progetti di interpretazione del linguaggio, scritto o parlato (Text Analysis, Classification & Conversation Systems). Il 22% per algoritmi che suggeriscono ai clienti contenuti in linea con le singole preferenze (Recommendation Systems). Il 10% analisi di video ed immagini, 7% Process Orchestration Systems, il 5% IA Generativa. Guardando alla spesa media in IA per azienda, ai primi posti Telco-Media e Assicurazioni, seguiti da Energy, Resource & Utility e Banche e Finanza.
La diffusione nelle aziende. Il 61% delle grandi imprese ha all’attivo, almeno a livello di sperimentazione, un progetto d’IA, mentre si scende al 18% tra le piccole e medie imprese. L’adozione nelle imprese è sostanzialmente stabile rispetto al 2022. Le aziende che avevano già avviato almeno una sperimentazione proseguono e accelerano. Nelle aziende in ritardo, sono invece rari i casi in cui l’avvento della IA generativa ha già dato vita ad una sperimentazione. Il 37% delle grandi realtà che non hanno progetti all’attivo ha intenzione di attivarli nei prossimi 12 mesi e si moltiplicano le iniziative di workshop ispirazionali/formativi sul tema. Circa 2 grandi aziende su 3 hanno discusso internamente delle applicazioni delle IA generative, tra queste una su quattro ha avviato una sperimentazione (il 17% del totale, dunque). D’altro canto, soltanto il 7% delle piccole e medie imprese sta riflettendo su potenziali applicazioni e solo il 2% ha concretamente attivato almeno una sperimentazione.
La maturità delle aziende L’Osservatorio della School of Management del Politecnico di Milano identifica 5 profili di maturità delle grandi organizzazioni nel percorso di adozione dell’IA. L’11% è avanguardista (in crescita di 2 p.p. rispetto al 2022), aziende che hanno raggiunto la piena maturità a livello tecnologico, organizzativo e gestionale nell’adozione di soluzioni di IA. Il 23% è apprendista, hanno diversi progetti avviati ma difficilmente impiegano metodologie strutturate nel gestirli e tendono a far ricorso a soluzioni standard o pronte all’uso. Nel restante 66% dei casi, permangono situazioni eterogenee: ci sono organizzazioni in cammino (29%), dotate degli elementi abilitanti ma con pochi progetti, e aziende che non percepiscono il tema come rilevante e non dispongono di un’infrastruttura IT adeguata alla gestione di grandi quantità di dati.
(Fine riquadro)
Molto dibattuto è oggi invece il rapporto tra IA e produttività. Lo sviluppo di una nuova tecnologia di frontiera crea infatti sempre una marcata attenzione sulle sue implicazioni in termini di efficienza nell’uso dei fattori produttivi: lo è stato con l’invenzione delle ferrovie, della radio e più recentemente di Internet. Goldman Sachs stima che l’IA possa generare guadagni di produttività tali da incrementare il PIL mondiale del 7% entro un decennio. Questo, in un periodo in cui la produttività ristagna (negli USA è cresciuta solo dello 0,53% nei dieci anni prima della pandemia), anche a causa del progressivo invecchiamento della popolazione che è ormai un tratto caratteristico di paesi che complessivamente determinano più del 75% dell’output del Pianeta. Come si spiega una ricaduta così rapida sul sistema socio-tecnico quando elettricità, ferrovie e computer (ovvero innovazioni simili all’IA) hanno impiegato molti anni prima di scaricare realmente sul sistema socio-tecnico il proprio potenziale in termini di migliore utilizzo delle risorse? Oggi è tutto più veloce e l’IA è ormai una tecnologia di cui si parla dagli anni ’50. L’IA è a portata di click del mouse, richiede ingenti risorse di calcolo e formazione del personale. Per questi motivi, tra gli altri, dovremo attendere ancora un paio di anni per formulare previsioni più precise. Anche se è innegabile che l’IA generativa sia in grado di liberare tempo umano attualmente dedicato ad attività codificate per portarlo su compiti a maggiore valore aggiunto. La magnitudo del fenomeno dipenderà ovviamente non solo dalla qualità del percorso evolutivo sul fronte strettamente tecnologico, ma anche da politiche fondate su una vera e propria discontinuità culturale. Più precisamente sarà necessario vedere l’IA non come un sostituto dell’uomo quanto, piuttosto, come una tecnologia a supporto delle attività umane. Determinante sarà la focalizzazione sulle attività che oggi presentano bassi indici di produttività così come un ruolo chiave verrà giocato dal sostegno offerto alle imprese per l’implementazione delle modifiche organizzative e gestionali necessarie per capitalizzare il potenziale dell’IA. È invece unanime l’orientamento a livello internazionale sul (grande) potenziale in termini di generazione di PIL conseguente alla diffusione (nel mondo industriale e della pubblica amministrazione) di pratiche basate sull’IA. A giugno 2023 è stato pubblicato un rapporto (Mc Kinsey) che ha stimato l’impatto economico dell’IA generativa per un valore superiore ai 4 trilioni di dollari, che si vanno ad aggiungere agli 11 trilioni che altre forme di IA e automazione sono in grado di innescare a livello globale. Si tratta di numeri enormi: basti pensare che il PIL della Germania è oggi di circa 4 trilioni. Si basano sul presupposto che la rivoluzione indotta dall’IA abbia caratteristiche distintive rispetto alle altre tecnologie digitali che si sono affermate negli ultimi 30 anni. Una spiegazione, in particolare, è riconducibile al fatto che l’IA ha esteso il raggio di impatto (rispetto alle altre tecnologie digitali): andando oltre l’esercizio di attività riconducibili a una serie di istruzioni e rendendo possibili, di converso, attività realizzate da macchine come il riconoscimento di oggetti, testi, audio, ecc. Nella sostanza, è emersa la possibilità, grazie all’IA generativa, di utilizzare le macchine digitali per molti più task, soprattutto quelli relativi ad attività ad alto contenuto di conoscenza (finanza, medicina, temi legali, pubblicità, ecc.) e/o tipiche dell’industria creativa. In termini più specifici, l’IA può impattare a differenti livelli della catena del valore. Può supportare processi decisionali a qualsiasi livello grazie alla possibilità di processare grandi moli di dati. Può contribuire alla gestione di attività produttive in virtù dell’automazione che è in grado di introdurre o migliorare le attività di controllo qualità come conseguenza di una sempre più evoluta abilità di computer vision. Nella sua componente generativa, gli effetti dell’IA (Figura 3.1) si concentrano prevalentemente in quattro aree: operazioni dei clienti, marketing e vendite, ingegneria del software e ricerca e sviluppo. Si intende fare riferimento, ad esempio, alla capacità dell’IA generativa di supportare le interazioni con i clienti (ricorrendo ad un grado sempre più elevato di personalizzazione), generare contenuti creativi per marketing e vendite e creare bozze di codici informatici basati su istruzioni in linguaggio naturale e molto altro.

Le imprese leader hanno vantaggi difficili da colmare Non si tratta di cambiamenti che mettono fuori mercato gli incumbent (Figura 3.2), ovvero le (grandi) imprese leader e in possesso di una tradizione consolidata. Al contrario, l’IA può contribuire al loro rafforzamento, per almeno tre ragioni. Vi è, in primo luogo, un tema di penetrazione di mercato: infatti, nel momento in cui aziende come Microsoft, Salesforce e SAP incorporano all’interno dei loro prodotti strumenti di IA, ben difficilmente verranno scalzate da nuovi player. Gli incumbent sono anche facilitati dall’accesso a dataset proprietari in grado di garantire prospettive di addestramento specifiche ai modelli di IA progettati. Vi è infine una ragione di ordine storico: anche nei periodi recenti caratterizzati dall’affermazione di rilevanti traiettorie di trasformazione digitale abbiamo assistito al fallimento di poche imprese consolidate. Solo 52 delle 500 imprese americane a maggior fatturato (Fortune 500) sono state create dopo il 1990, sette dopo il 2007 (anno di lancio dell’iPhone). Al contrario, 280 sono state fondate prima che gli USA prendessero parte alla Seconda Guerra Mondiale.

IA pervasiva sul sistema manifatturiero. La presenza di sistemi di IA nel mondo manifatturiero non è nuova; i recenti sviluppi in ambito computazionale (velocità di calcolo) e la crescente disponibilità di dati hanno accelerato di molto la loro adozione e amplificato gli impatti a livello operativo e a livello strategico (Figura 3.3). Sul fronte operativo, possiamo ormai considerare il machine learning, i sistemi di robotica avanzata e gli analytics sui dati come strumenti che compongono una cassetta degli attrezzi sempre più rilevante a supporto del management aziendale. Per essere ancora più chiari, è ormai fuor di dubbio che l’IA può contribuire a modificare quasi ogni ambito delle operations aziendali. A partire dalla pianificazione della produzione, che, come noto, è un compito particolarmente complesso. Esso richiede l’utilizzo di un numero molto ampio di variabili operative (persone, attrezzature e impianti, materie prime, magazzini e logistica) che si devono coniugare con esigenze di natura competitiva nonché obiettivi manageriali. In questo quadro, l’IA permette di gestire al meglio questo ampio set di variabili rendendo possibili analisi di scenario in tempo reale e processi di ottimizzazione in contesti contraddistinti da una elevata variabilità della domanda.

Allo stesso modo, i sistemi di IA rendono possibile il perseguimento di obiettivi di ottimizzazione operativa del singolo processo grazie alla possibilità di (i) identificare colli di bottiglia e altre forme di inefficienza e (ii) svolgere (in virtù dell'utilizzo combinato di tecniche di machine learning e tecnologie robotiche) con maggiore precisione ed efficienza azioni precedentemente svolte dall’uomo. Non meno rilevante, anzi per certi versi ri-fondativo, è il ruolo che l’IA assume nella attività di controllo qualità. Queste, pur essendo basate sull’utilizzo di tecnologie avanzate (come gli infrarossi, gli ultrasuoni e non solo) si sono sempre connotate per una significativa presenza dell’intervento umano e di una probabilità non piccola di errore. La disponibilità di sistemi di IA evoluti (machine learning e computer vision) rende possibile, da un lato, una piena automazione del controllo e, dall’altro, la minimizzazione degli errori (associati alla identificazione di anomalie).
L’IA è d’altro canto uno strumento molto utile per ottimizzare la gestione della supply chain grazie alla possibilità di gestire livello delle scorte (ai differenti livelli), logistica e dimensione degli acquisti grazie alla possibilità di coordinare al meglio le esigenze specifiche a livello di singola unità organizzativa con l’andamento delle previsioni della domanda. Anche le attività di formazione e assistenza del personale impiegato nelle attività di produzione e manutenzione ne possono trarre un grande beneficio: i sistemi di elaborazione del linguaggio naturale in combinazione con sistemi di realtà aumentata e/o virtuale l’IA possono infatti fornire supporto personalizzato e in tempo reale agli operatori coinvolti in un task che non riescono a gestire autonomamente.
L’IA generativa (e non solo) è evidentemente anche uno strumento molto rilevante a supporto dell’attività di progettazione di nuovi prodotti/tecnologie, non in chiave sostitutiva del progettista quanto piuttosto come strumento a supporto della definizione di archetipi concettuali generati secondo una prospettiva analogica sui dati/progetti del passato e, in quanto tali, possono contribuire ad alimentare il pensiero discontinuo tipico della progettazione umana di innovazioni radicali. L’IA può infine contribuire a (meglio) conseguire obiettivi complessi e sistemici quale quello della sostenibilità ambientale. In particolare, grazie alla possibilità di analizzare in tempo reale l’impatto ambientale di ogni attività mentre è in esecuzione, diviene possibile introdurre azioni correttive in modo super tempestivo innescando così continui cicli di feedback che non solo migliorano le prestazioni ambientali ma riducono consumi di energia e scarti contribuendo a migliorare l’efficienza operativa del sistema produttivo.
È interessante osservare come l’entità dei benefici conseguibili a questo livello dipenda dall’utilizzo combinato di più tecnologie: più precisamente, in questo caso, IA e digital twin, ovvero gemelli digitali, intesi come versioni immateriali del sistema produttivo in grado di riprodurne il funzionamento.
Sul fronte strategico, un utilizzo consapevole dell’IA diviene strumento di cambiamento del modello di business aziendale. L’utilizzo combinato di tecnologie 5G, infrastrutture cloud, analisi dei big data può infatti dar luogo ad un sempre più marcato orientamento della manifattura verso un paradigma di servitizzazione. In particolare, grazie alla possibilità di ospitare e processare sulla nuvola moli enormi di dati (relativi al funzionamento degli apparati/impianti proposti al mercato) è possibile per il top management aziendale identificare flussi aggiuntivi di ricavi e/o progettare nuova modalità di gestione della relazione impresa-mercato. In termini aggiuntivi, si fa riferimento alla possibilità di ottenere benefici addizionali a fronte del servizio di manutenzione predittiva.
Secondo una prospettiva ancora più radicale, big data, cloud e IA diventano invece determinanti chiave per modificare in misura sostanziale il processo di scambio con il mercato: dal trasferimento di proprietà di un bene/tecnologia al “job to be done” ovvero l’offerta di un servizio che garantisca il corretto funzionamento (secondo un service level agreement concordato) di quel bene/tecnologia.
Il cambiamento che nel complesso è richiesto alle imprese è davvero significativo; come evidenziato all’inizio di questa riflessione, l’IA rappresenta un driver trasformativo della catena del valore con effetti significativi su organizzazione, tecnologie e persone. È proprio in questa prospettiva che è facile immaginare la presenza di non pochi ostacoli ad una sua piena diffusione nell’ambito del sistema industriale. In proposito, si può fare riferimento a una recente ricerca presentata al World Economic Forum che ha evidenziato, grazie ad una indagine empirica, l’esistenza di cinque principali sfide (Figura 3.4) che, se non adeguatamente affrontate possono limitare, e non di poco, la diffusione dell’IA. Si fa in particolare riferimento a:
Mancata corrispondenza tra capacità dell’IA ed esigenze operative. Molto spesso si verifica infatti che, a causa di una non corretta analisi preliminare, l’IA non riesce a risolvere il problema riscontrato e questo ne limita la diffusione a livello di operations aziendali;
Assenza di un approccio strategico e di una comunicazione autorevole. Senza i giusti sponsor e leader coinvolti, l’adozione di soluzioni di IA in una impresa ne risulta fortemente limitata a causa delle barriere al cambiamento che inevitabilmente innesca per via della componente trasformativa insita in ogni progetto di IA;
Competenze insufficienti all’intersezione tra IA e operations. Per avere successo, le applicazioni IA richiedono sviluppo e implementazione da parte di team inter-funzionali con competenze diverse nella convergenza di IT, tecnologia operativa (OT), dati e tecnologie IA;
Disponibilità di dati e assenza di una struttura di data governance. Solo attraverso la condivisione di dati all’interno dell’azienda è possibile definire sistemi di addestramento in grado di rendere realmente efficaci le applicazioni di IA;
Carenza di modelli di IA intellegibili nel mondo manifatturiero. La percezione dei modelli di IA come sistemi complessi, non trasparenti e non interpretabili ostacola la loro distribuzione. I produttori hanno bisogno di modelli di IA che siano aperti e trasparenti per creare fiducia nelle previsioni e nei risultati specifici o interpretabili affinché gli esperti del settore li accettino.

Si riportano nel seguito alcuni esempi di utilizzo dell’IA a supporto di progetti di cambiamento realizzati a livello di operations.
L’utilizzo di BMW del metaverso di NVIDIA e dell’IA per la realizzazione di una fabbrica virtuale. NVIDIA ha aperto la prima fabbrica virtuale al mondo nel NVIDIA Omniverse per conto del Gruppo BMW. La piattaforma NVIDIA Omniverse permette a BMW di ottimizzare i layout, la robotica e la logistica del suo stabilimento per veicoli elettrici previsto a Debrecen, in Ungheria. Tutto questo avviene prima ancora che inizi la produzione reale. Questo approccio digitale consentirà a BMW di pre-ottimizzare il design della fabbrica in modo virtuale e di sfruttare l’IA per eliminare ordini di modifica costosi e ridurre i tempi di inattività della produzione. L’alleanza tra NVIDIA e il BMW Group dimostra la potenza e l’agilità di portare uno stabilimento di produzione industriale guidato dall’IA a un livello completamente nuovo.
General Electric (GE) utilizza software di IA per l’industria manifatturiera sostenibile. GE ha presentato un nuovo software chiamato GE Vernova Proficy che raccoglie dati sulla sostenibilità per aiutare le strutture industriali a raggiungere i loro obiettivi di sostenibilità riducendo nel contempo i relativi costi. Il software di IA integra dati operativi e di sostenibilità per ottimizzare l’uso delle risorse e gestire le metriche climatiche per la conformità normativa. Un produttore automobilistico in Europa ha utilizzato Proficy per ottenere un risparmio energetico del 18% sui sistemi di riscaldamento della fabbrica.
Amazon impiega robot basati sull’IA per migliorare i tempi di consegna e ridurre gli infortuni. Il nuovo sistema robotico basato sull’IA di Amazon è in grado di migliorare significativamente la sicurezza, l’efficienza e le operazioni complessive nei suoi magazzini. La tecnologia ha il potenziale per aumentare la velocità di ricerca e stoccaggio dei prodotti fino al 75% e l’evasione degli ordini del 25%, utilizzando bracci robotici e una visione computerizzata avanzata per identificare l’inventario e semplificare il processo di consegna. Inoltre, questo braccio robotico basato sull’IA mira a eliminare le attività banali e a ridurre significativamente gli infortuni sul lavoro facendo collaborare umani e robot per ottenere risultati ottimali.
Il progetto di INTEL basato su IA in ambito manifatturiero. L’approccio basato sull’IA di Intel all’analisi della resa nella produzione di semiconduttori rappresenta un importante cambiamento verso il paradigma dell’Industria 4.0. Questa soluzione dimostra il potenziale dell’IA trasformando i processi di produzione, offrendo una maggiore scalabilità e una maggiore efficienza. Automatizzando il rilevamento delle aree di guasto lordo (GFA) e applicando la risoluzione proattiva dei problemi, l’IA consente un’analisi dei wafer al 100%, il rilevamento di più problemi e la condivisione delle conoscenze tra i siti di produzione globali rapidamente. Questo approccio aiuta Intel non solo a migliorare la resa della produzione e ridurre il time-to-market, ma libera anche gli ingegneri per dedicare il loro tempo a progetti complessi e alla risoluzione dei problemi.
Airbus sfrutta l’IA e la computer vision per automatizzare l’ispezione degli aeromobili. Nei complessi processi produttivi del settore della produzione di aeroplani, Airbus sta sfruttando l’IA per rivoluzionare le metodologie di controllo qualità. Analizzando costantemente i feed video, le soluzioni basate sull’IA registrano in modo preciso e automatico le principali fasi di assemblaggio, escludendo completamente la possibilità di errore umano. Questa soluzione, sviluppata in collaborazione con Accenture Labs, si fonda sull’uso della computer vision assistita dall’IA per rilevare i problemi di produzione nell’assemblaggio finale dell’aeromobile. Può anche riconoscere quando le attività sono state completate tramite movimento, annotazione di immagini e feed video per ispezionare la corretta installazione di grandi parti dell’aereo. Questo processo automatizzato utilizzato da Airbus aumenta non solo la precisione e l’efficienza, ma genera anche tempo libero per i tecnici per concentrare la loro attenzione su attività più significative, con conseguenti risparmi complessivi e una qualità migliorata senza sacrificare gli standard di sicurezza.
Toyota utilizza l’IA per la progettazione delle auto. Toyota ha deciso di ricorrere alla potenza dell’IA nei suoi processi di progettazione. Sta dotando i suoi ingegneri di tecnologie di IA generativa, realtà virtuale e realtà aumentata per esplorare nuove possibilità di progettazione, migliorare le metriche delle prestazioni e aumentare la sicurezza dei suoi veicoli. Queste tecnologie promuovono la creatività tra i progettisti incorporando vincoli ingegneristici nei modelli Gen-AI, riducendo le iterazioni necessarie per conciliare la progettazione.
(Fine riquadro)
IA e manifattura italiana: una relazione pericolosa. I settori di elezione del sistema manifatturiero italiano, in cui l’ambito delle macchine utensili rientra a pieno titolo, fondano, come noto, la loro competitività su una prospettiva di eccellenza tecnica di prodotto e di produzione. Non è un caso che l’Italia sia percepita come la patria della produzione di qualità. È questo un posizionamento che il nostro sistema industriale è riuscito a conseguire grazie alla convergenza di un patrimonio culturale ultramillenario, che ha dato luogo a un approccio pressoché unico nel mondo e una capacità di orientare la tecnologia in manufatti/impianti pienamente rispondenti alle esigenze di mercato. Le nostre imprese sono, in altre parole, figlie di una legacy manifatturiera in cui il prodotto è elemento chiave del vantaggio competitivo e il dato molto spesso rappresenta componente secondaria sia a livello di processo produttivo che di prodotto. L’IA fonda però la sua centralità nella possibilità di utilizzare grandi banche dati di qualità. Ed è proprio qui che il Made in Italy deve fare un profondo esame di coscienza: siamo pronti a cavalcare questa rivoluzione o rischiamo di esserne travolti?
L’energia elettrica ha ridefinito il mondo, dal lavoro alla geopolitica, rivoluzionando la vita quotidiana di miliardi di persone. Se l’IA promette un impatto simile, la domanda non è se, ma come ci prepareremo. Gli avvertimenti ci sono già, e arrivano dall’automotive. Le difficoltà di Volkswagen e Stellantis sono la prova di una strategia sbagliata: miliardi di euro investiti senza comprendere che la transizione digitale richiede un cambio di paradigma nella progettazione stessa. Non basta innovare il prodotto; occorre reinventare l’oggetto automobile e l’ecosistema che ruota intorno ad esso: non è un caso che i cinesi abbiano costruito catene del valore completamente nuove in cui gli attori del mondo digitale giocano un ruolo chiave (Huawei, Xiaomi, Baidu). E allora, guardiamo al nostro sistema industriale. L’export italiano, con la sua identità intrisa di tradizione e qualità, deve evolversi in un’era dove il vantaggio competitivo non si gioca più solo sul “che cosa” si offre, ma sul “come” lo si offre. La competizione non è più solo sul prodotto fisico, ma sull’esperienza di mercato che lo accompagna. L’IA, in questo contesto, non è solo un mezzo, ma il nuovo cuore pulsante di un nuovo sistema produttivo che, lavorando sul dato, è in grado di veicolare al mercato esperienze di valore.
In questo quadro, tre sono le grandi sfide da affrontare. Due fanno riferimento a leve a disposizione delle imprese. Primo, il controllo dei dati e della relazione con il cliente. Le esperienze personalizzate saranno il nuovo oro, e l’export italiano deve smettere di dipendere da intermediari che monopolizzano l’accesso al mercato finale; l’IA ci spinge ineluttabilmente verso il controllo della relazione con il cliente/mercato. Secondo, la necessità di abbandonare i vecchi paradigmi fordisti: la specializzazione verticale, pensata per le economie di scala nella produzione, lascia il posto all’integrazione orizzontale. Pertanto, pur essendo l’IA un driver di automazione, richiede un’inversione a U rispetto all’automazione in ambito manifatturiero: l’automazione riconducibile alla sua adozione può essere ottenuta solo attraverso “apertura orizzontale”, la rottura dei silos organizzativi così da integrare basi di dati che spesso risiedono in unità differenti e non sono comunicanti.
Infine, serve una nuova infrastruttura sistemica in grado di sostenere sperimentazioni e progetti di un sistema fatto da piccole imprese che non sono in grado di muoversi autonomamente nella direzione di un consapevole sviluppo di motori di IA. La potenza di calcolo sarà il carburante di questa rivoluzione, ma siamo davvero pronti tenuto conto che la scala degli investimenti necessari lavora su multipli di centinaia di milioni di euro? L'architettura di High Performance Computing a Bologna è un gioiello sottoutilizzato e, in chiave prospettica, probabilmente non sufficiente. Sia il sistema delle imprese che la politica dovrebbero impegnarsi maggiormente nella diffusione dell’IA a tutti i livelli. È sicuramente importante chiedersi quanto si intenda affidare a un partner così rilevante come gli USA la scrittura delle regole del gioco in questo ambito. Nella consapevolezza che il vantaggio competitivo non risiede più nella fabbrica tradizionale, ma nella capacità di interpretare il mercato attraverso i dati e di trasformarli in esperienze di valore. Andrebbe anche smussata l'idea che i cinesi vincano solo grazie ai sussidi: il loro progresso è una lezione di strategia che ignoriamo a nostro rischio e pericolo.
La competitività dell’export italiano ha bisogno di una scossa. La domanda non è se l’IA cambierà il mondo, ma se Italia ed Europa saranno protagoniste di questo cambiamento o solo spettatrici di un’opportunità persa.
Uno sguardo al futuro. A dispetto dell’evidente potenziale impatto positivo dell’IA, sono molti coloro che concentrano la loro attenzione sulla minaccia e le criticità riconducibili a una sua diffusione (non controllata). In particolare, grande attenzione è posta sul fatto che i Large Language Models (LLM) non sono al 100% affidabili in quanto gli output prodotti potrebbero risentire dei bias insiti nei training set utilizzati per addestrare i modelli. Un altro mal di pancia particolarmente diffuso riguarda il potenziale effetto sostitutivo che l’IA può innescare, grazie all’automazione, nei confronti degli esseri umani. Si tratta di timori fondati, basati su evidenze oggettive, e, in quanto tali, necessitano di essere tenuti nella giusta considerazione. Tuttavia, proprio in ragione di un obiettivo di tutela della qualità e quantità dell’operato umano, sarebbe più opportuno assumere una prospettiva diversa, di natura costruttiva fondata su tre presupposti di fondo.
Il primo fa riferimento al fatto che sarà la strategia (e non la tecnologia) a fare la differenza. In particolare, le imprese avranno successo solo se ricorreranno a modelli di business a piattaforma e non si focalizzeranno su tecnologie proprietarie. Le piattaforme garantiscono accesso a un pool di risorse standard in grado di garantire alle imprese una maggiore focalizzazione su leve e aspetti che fanno la differenza. Del resto, sull’ecosistema dell’Apple store, le imprese si avvantaggiano della possibilità di utilizzare gli strumenti che mette a disposizione Apple e che permettono di ridurre tempi di sviluppo.
Allo stesso modo la competitività di un singolo Paese dipenderà in senso stretto dalla capacità dei soggetti istituzionali di rendere disponibili agli operatori economici basi di dati country specific in grado di garantire un adeguato sviluppo dei motori di IA che tenga in conto dei fattori culturali distintivi e differenziali in senso competitivo del sistema-Paese. Il secondo presupposto fa invece riferimento al modo in cui si guarda al rapporto tra uomo e tecnologia (di IA). In questa prospettiva, sarà necessario leggere l’IA come una opzione virtuosa per aumentare (e non sostituire) il potenziale umano. In qualche modo occorre immaginare che uomini e macchine collaborino e competano tra loro simultaneamente come una squadra di atletica che gareggia in varie competizioni. In alcune, come la corsa dei 100 metri, i compagni di squadra competono tra loro. In altre, come la staffetta, lavorano insieme per un obiettivo comune. In questa relazione duale, persone e sistemi di IA necessitano di skill competitive e collaborative. Le prime si riferiscono ai vantaggi specifici di ciascuna delle parti. Le seconde fanno riferimento alla capacità dell’uomo e dell’IA di lavorare insieme. È pertanto fondamentale, secondo questa chiave simbiotica tra individui e IA, che si trovi il giusto bilanciamento tra investimenti in competenze delle persone e in tecnologia: nella consapevolezza che l’IA non può sostituire il lavoro umano ma lo può certamente trasformare.
Il terzo e ultimo pilastro riguarda invece il tema dell’evoluzione del sistema delle competenze che maestranze e manager dovranno possedere. Si tratta di una sfida rilevante per tutte le geografie ma assume un rilievo cruciale per l’Italia: a oggi quartultimo Paese in Europa per livello di competenze digitali e ultimo per livello di istruzione. È in particolare del tutto prioritario che si sviluppi una conoscenza adeguata su almeno tre versanti:
Nel complesso, è quantomai opportuno che si affermi nel sistema socio-tecnico una prospettiva di automazione a somma positiva, ovvero un’architettura che integra IA e attributi umani con l’obiettivo di aumentare la produttività (grazie all’IA) e la flessibilità (in virtù del contributo cognitivo di natura umana). La valorizzazione delle sinergie e non la sostituzione di un sistema (umano) con un altro (fondato su IA) dovrebbe essere in altre parole il mantra principale che caratterizza le politiche industriali dei Governi e le strategie di business delle imprese.
Le sfide a livello di sistema. A dispetto del suo enorme potenziale, è difficile pensare che l’IA sarà in grado di dispiegare ricadute positive rilevanti se il suo sviluppo sarà lasciato unicamente a “forze di mercato”. La massimizzazione dei benefici conseguenti a questa tecnologia sarà resa possibile dall’adozione di un approccio proattivo di natura bi-focale: che considera, cioè, i rischi indotti da uno sviluppo senza regole dell’IA e nel contempo mette in campo politiche sostenibili per una diffusione matura di questa tecnologia non più emergente. È infatti necessario prevenire un cattivo utilizzo della stessa. È in particolare necessario anticipare e gestire alcune fonti di potenziali problemi.
Il primo ha a che fare con le frodi e la personificazione di altri individui. Nulla di nuovo in verità sotto il sole, in quanto tali abusi risalgono a quando gli esseri umani si riunivano in gruppi abbastanza grandi da non conoscere tutti personalmente. Naturalmente, l’IA fornisce nuovi metodi, come la rappresentazione vocale o i video deep fake, particolarmente adatti a una società in cui gran parte dell’interazione è remota e digitale. Le soluzioni sono in parte legali – definendo la responsabilità per la comunicazione e i requisiti per un comportamento onesto, come il “watermarking” per il quale l’UE e gli Stati Uniti stanno individuando una via regolamentare. Un secondo problema riguarda l’impropria monetizzazione di dati personali e di comportamenti online di individui. Si tratta in fondo del nucleo centrale del business digitale, il cosiddetto capitalismo di sorveglianza, con cui ci confrontiamo da decenni. Anche in questo caso non si tratta di ricorrere a nuovi strumenti quanto piuttosto di adattarli e usare seriamente quelli di cui disponiamo.
Vi sono inoltre i rischi associati non tanto a danni intenzionali ma a effetti imprevisti significativi. Ad esempio, l’uso dell’IA da parte delle società finanziarie potrebbe portare all’instabilità finanziaria se molti partecipanti al mercato si affidassero inconsapevolmente allo stesso modello. Rischi analoghi possono emergere in altri settori. In questo caso, è evidentemente necessario acquisire consapevolezza a priori, grazie all’esperienza maturata, che vi sono ambiti in cui rischi precedentemente insospettati tendono a insinuarsi fra di noi.
Vi sono anche da considerare gli effetti dell’IA su redditi, benessere e soprattutto sulla loro distribuzione nella società. Vi è infatti il timore (fondato) che si possa innescare una dinamica di disoccupazione e/o di differenziazione con riferimento a persone in possesso di livelli differenti di istruzione. L’ultimo, ma non meno rilevante, tema, di natura economica, riguarda i diritti di proprietà – compresi i diritti di proprietà intellettuale – che devono essere definiti nel nuovo contesto. Questo vale per i “prodotti” dell’IA (idee immateriali e la loro applicazione), quindi stiamo parlando di diritti d’uso, royalties, possibilità di concedere in licenza. Riguarda anche le possibilità di utilizzo di dati generati da altri a fini di addestramento degli algoritmi di IA.
Inoltre, è indispensabile la progettazione di politiche (industriali) che promuovano l’utilizzo dell’IA nella società. In termini più concreti, ciò significa in primo luogo interpretare l’IA come un complemento e non un sostituto del lavoro umano: si tratta di un’azione che richiede continue interazioni con portatori di interessi dei lavoratori e delle imprese perché prevalga un atteggiamento consapevole, razionale e non un atteggiamento emotivo da caccia alle streghe. È importante d’altro canto che le istituzioni si facciano carico di esercitare una spinta pervasiva e trasversale (in tutti i settori e a tutti i livelli sociali) sull’uso dell’IA: onde evitare che si inneschino effetti di sperequazione cognitiva, che potrebbero amplificare le divergenze tra strati diversi della società.
Vi è inoltre, come già evidenziato, un tema di governance internazionale dell’IA. L’obiettivo deve essere quello di affermare un utilizzo sano della tecnologia e di evitare eccessive discrasie in termini di diffusione delle pratiche di utilizzo. Deve essere infine posta grande attenzione ai sistemi educativi: non tanto e solo per formare gli individui a un utilizzo sofisticato quanto anche per affermare valori inerenti a una corretta e trasparente gestione della catena del valore del dato.
Il potere trasformativo dell’IA è emerso in tutta la sua evidenza nell’ambito di questa riflessione. L’IA generativa ha, in particolare, esplicitato a tutti noi il contributo che questa tecnologia può fornire in termini di intelligenza aumentata degli individui. Come ogni rivoluzione, il processo di sviluppo dell’IA richiede una governance adeguata, molto diversa da quella che si è portata avanti negli ultimi anni in Europa con riferimento al processo di più ampia trasformazione digitale della società. La tutela dei diritti (ad esempio, la privacy) è certamente importante ma essa non può assurgere a valore assoluto; se il diritto alla privacy impedisce lo sviluppo di sistemi di IA e questo riduce la competitività delle imprese causando licenziamenti a catena, risulta evidente che la prospettiva regolatoria va a confliggere con quella di sostenibilità economica e sociale e, in questo senso, deve essere rimossa.
Anziché una (inutile) primazia regolatoria europea, serve dunque un sistema di regole globali in cui sono coinvolti e si rendono responsabili USA, Europa e Cina; è questa una sorta di condizione necessaria per garantire che la competizione si giochi sullo stesso terreno e si eviti, ad esempio, quanto si sta verificando sul fronte ambientale dove l’Europa gioca il ruolo di leader sul fronte normativo penalizzando nei fatti l’industria domestica per il fatto che le imprese al di fuori del Vecchio Continente, da un lato, operano in un ambiente meno restrittivo e, dall’altro, possono comunque vendere i propri prodotti in Europa.
Serve inoltre una governance “agile”, che tenga conto del fatto che la velocità di sviluppo dell’IA richiede un continuo adattamento e/o modifica degli obiettivi di governance: nulla può essere calcificato in una regola statica. È invece utile adottare la politica del bersaglio mobile per tenere conto della necessità di continuo adattamento degli obiettivi. Non meno rilevante è il livello di inclusività della governance, che deve prevedere il coinvolgimento anche degli attori privati; questo significa che il “buon governo” dell’IA richiede di andare oltre una visione stato-centrica in quanto i singoli Governi non controllano e non sempre capiscono l’IA. Le imprese private, che non godono di sovranità nel senso tradizionale, detengono invece potere reale e capacità di azione nello spazio digitale e, in quanto tali, devono essere messe nelle condizioni di co-creare lo schema di regole a cui tutti gli attori si devono attenere.
Nel complesso serve una visione positiva di quello che l’IA può fare e delle misure necessarie per trasformare la visione in realtà. Infatti, il rischio maggiore non è quello di produrre una catastrofe civile o un enorme shock negativo per l’occupazione. Piuttosto, senza una guida efficace, le innovazioni dell’IA potrebbero essere sviluppate e implementate in modi che semplicemente amplificano le attuali disparità economiche piuttosto che portare a un’economia globale rafforzata per le generazioni a venire.
Da ultimo ma non meno importante è la presa di coscienza che l’IA è sì una tecnologia dal potenziale elaborativo immenso, facile da usare, ma ha anche evidenti limiti. È in primo luogo ancora immatura destinata a subire evoluzioni molto significative con l’arrivo del quantum computing; è d’altro canto riconducibile a rielaborazioni statistiche (anche molto sofisticate) delle informazioni fornite in ingresso e, in quanto tale, non possiamo aspettarci che sia fonte delle idee più innovative, che si distaccano, cioè, dal pensiero comune. L’IA in altre parole non è generatrice di diversità quanto piuttosto di isomorfismo comportamentale e questo ne rappresenta un significativo punto di debolezza; la diversità gioca infatti molto spesso un ruolo cruciale nel generare dinamismo ed energia. Ad esempio, l’energia elettrica non potrebbe esistere senza una differenza di potenziale tra due punti: è proprio questo squilibrio che genera il flusso di corrente.
Anche per questa importante ragione, non è pensabile che l’IA sostituisca l’essere umano; come molti studi hanno evidenziato con riferimento a tecnologie del passato, anche l’IA non eliminerà il lavoro ma lo cambierà. Questa è la più importante consapevolezza che dobbiamo tutti maturare: bloccarla è sbagliato, favorirne la diffusione semplificherà la vita a persone e aumenterà la produttività delle imprese. Il nocciolo della questione è superare la paura e abbracciare il cambiamento. La sfida dell’IA è anche una sfida di fiducia e visione ed è indispensabile una decisa accelerazione nella sua adozione.
L'area dell'America Latina e Caraibi (ALC) negli ultimi anni sembra aver intrapreso una strada virtuosa in direzione della crescita economica. Secondo le stime della Banca Mondiale, nel 2024 il tasso di crescita del PIL dell’area ALC è atteso intorno al +1,9%, e la previsione per il 2025 è di un +2,6%. La crescita fatta registrare fin qui, e che si prevede per il futuro, rimane però inferiore rispetto alle previsioni per le altre principali aree geografiche. Tassi di crescita nettamente positivi, ma inferiori a quelli previsti per le altre principali aree di interesse economico, sono un chiaro segnale di come la regione disponga di un notevole potenziale inespresso anche alla luce del suo peso demografico: al 2024 l’area dell’ALC conta una popolazione totale di circa 663 milioni di persone. Questo dato va però contestualizzato alla luce dell’eterogeneità delle specifiche realtà-paese che vengono a confluire nell’area geografica dell’ALC. Secondo le stime della Banca Mondiale, i tassi di crescita attesi e previsti risultano particolarmente eterogenei, ma in larga misura positivi. Infatti, se tra le maggiori economie (Brasile, Cile, Colombia e Messico) della regione i tassi di crescita attesi per il 2024 risultano positivi ma contenuti (rispettivamente, 2,8%; 1,5%; 2,5% e 1,7%). Fa eccezione l'Argentina (-3,5%), che però ha intrapreso un cammino rigoroso di risanamento dei conti pubblici e l'adozione di politiche monetarie volte a riportare l'inflazione su livelli accettabili, fattore indispensabile per riavviare qualsiasi politica di rilancio dell'economia negli anni avvenire. Le altre economie di piccole dimensioni risultano in ascesa con tassi attesi di crescita sensibilmente superiori ai colossi della regione; esempi particolarmente interessanti sono dati dalla Guyana, che con un tasso di crescita atteso per il 2024 del 43% ed un tasso di crescita previsto per il 2025 del 12,3% si posiziona al primo posto come “piccola” economia in maggiore ascesa. Altro caso interessante risulta la Repubblica Dominicana che nel 2024 ci si attende cresca del 5,1% e nel 2025 del 4,7%.
Le recenti prospettive di crescita fin qui delineate per la regione possono essere comprese, in prospettiva, alla luce delle tendenze in atto negli USA di nearshoring o friendshoring, che potrebbero rappresentare un'ulteriore opportunità per i paesi dell’ALC di attrarre la dislocazione di attività produttive sul proprio territorio alla luce del vantaggio competitivo dovuto alla vicinanza geografica con gli Stati Uniti. Come evidenziato nello stesso documento della Banca Mondiale, la guerra dei dazi tra Stati Uniti e Cina ha parzialmente contribuito ad ampliare i rapporti commerciali tra i paesi dell’area ALC e gli Stati Uniti. Seppur con ordini di grandezza diversi fra paesi, in generale l’area dell’America Latina e Caraibi ha parzialmente sostituito la Cina quale principale partner commerciale soprattutto per particolari tipologie di prodotti – quali i macchinari e gli apparecchi elettronici.
In questo contesto, in particolare, Messico e Nicaragua hanno beneficiato più di altri paesi dalle tensioni tecnologiche e commerciali tra i due colossi mondiali. La ragione sembrerebbe essere prettamente geografica, vista la vicinanza dei due paesi con gli Stati Uniti. Per il Messico va però anche considerata la sua adesione all’accordo NAFTA, che ne agevola nettamente i rapporti commerciali con gli USA. In termini di categorie di prodotti, i due paesi centro-americani hanno incrementato il proprio export negli USA, in sostituzione di quello cinese, soprattutto per quanto riguarda i macchinari e gli apparecchi elettronici. Interessante risulta l’incremento dell’export tessile del Nicaragua, che sembrerebbe mimare, con le adeguate proporzioni, il “caso Vietnam”. L’allargamento della componente export dei bilanci commerciali dei paesi ALC apre le porte a una maggiore dinamicità anche dal lato import. Le politiche economiche messe in atto – volte specialmente a contenere l’inflazione e ad allargare il tessuto produttivo – contribuiscono a rendere la regione un mercato in forte espansione e, quindi, un importante terminale di sbocco per particolari tipologie di macchinari, funzionali alle politiche economiche e industriali adottate.
L’aumento delle prospettive di crescita dell’export per le economie latino-caraibiche, specialmente verso gli Stati Uniti, ma non solo, potrebbe aprire a scenari particolarmente favorevoli per le possibilità di esportazione nella regione. Negli ultimi anni, le maggiori economie dell’area ALC si sono distinte per la capacità di mantenere pressoché in equilibrio la propria bilancia commerciale. Questa dinamica è stata resa possibile grazie ad aggiustamenti fiscali, ma anche a causa di un crollo degli investimenti. Questo elemento potrebbe risultare determinante per l’ampliamento delle opportunità di esportazione per le principali economie mondiali, Italia inclusa.
In aggiunta, la graduale transizione delle principali economie latino-caraibiche verso un tessuto industriale più diversificato contribuisce a rendere la regione un mercato altamente dinamico e in espansione.
Forte presenza dell’Italia nell’area ALC. In questo contesto, è fondamentale per l’Italia consolidarsi come un partner commerciale forte e credibile nella regione. In parte, il nostro Paese sembra già aver intrapreso la strada giusta. La quota dell’export totale italiano detenuta dall’area ALC si attesta, al 2023, al 3,1%. Nel 2023, il valore totale dell’export italiano nell’area, considerando tutte le categorie di prodotti, è stato di circa 19,3 miliardi di euro, con un tasso di crescita medio annuo (CAGR) del 3,6% dal 2014. I principali partner commerciali risultano essere il Brasile, con una quota dell’export totale nel 2023 del 28,2%, e il Messico con una quota nel 2023 del 32,9%. Seguono, a notevole distanza, l’Argentina (7,2%) e il Cile (6,8%). Tra i quattro principali partner commerciali, le maggiori prospettive sono offerte dal Messico, che registra una crescita media annua dell’import di prodotti italiani nello stesso orizzonte temporale del +7,2%, e il Cile che fa registrare, nello stesso arco temporale, un +4%. Argentina e Brasile, invece, si attestano rispettivamente ad un +2,7% e +1,2%.
L’export di macchinari va meglio nei paesi ALC rispetto al resto del mondo. Viste le prospettive di crescita del tessuto industriale e produttivo dell’area, capire il posizionamento italiano nell’export di beni ACT verso quest’area risulta fondamentale. In termini generali, il peso dell’area dellALC sulle esportazioni italiane di beni ACT si attesta all’8,3% al 2023. Rispetto invece all’export totale (considerando tutte le tipologie di prodotti), il comparto dei macchinari ACT detiene una quota, al 2023, del 13,8% (quota che, se si considerano tutte le destinazioni, risulta pari al 4,9%). La dinamica dell’export ACT italiano nei paesi dellALC è stata fortemente positiva, ed è in crescita nel periodo post-pandemico. Infatti, l’export di beni strumentali nell’area ha fatto registrare una crescita media annua (CAGR) del +6,7% tra il 2018 e il 2023, a fronte di una crescita media verso il resto del mondo pari al 2,2% (Grafico 4.1).
La variazione percentuale delle vendite, tra il 2018 e il 2023 dell’export di beni ACT verso il mondo, esclusa l’area dell’ALC, ha registrato un incremento del +11,5%. Restringendo il focus solo all’area ALC, il valore delle vendite è invece incrementato di un sorprendente +38,2% nello stesso arco temporale. Questo incremento risulta particolarmente interessante se si considera che tra il 2018 e il 2019 e il 2019 e il 2020 le variazioni dell’export italiano nell’area ALC sono state negative, e rispettivamente pari a -7,3% e -14,5%. Da qui, gli anni post-pandemici (2021, 2022 e 2023) segnano un importante salto in avanti dell’export ACT nell’area. Nel dettaglio, l’export nell’area ALC ha registrato variazioni del +25,1% tra il 2020 e il 2021, del +23,7% tra il 2021 e il 2022 e del +12,7% tra il 2022 e il 2023. Questi numeri evidenziano chiaramente come l’area dell’ALC risulti un mercato particolarmente dinamico e permeabile all’export ACT italiano.

Più recentemente l'export di beni ACT nell’area ALC cresce di più rispetto alle altre categorie di beni. In generale, per quanto riguarda l’export di beni Made in Italy (esclusi i macchinari), l’area ALC ha fatto registrare un aumento dell’import pari a quello del solo comparto dei macchinari. Nel quinquennio 2018-2023, l’export italiano (escludendo i macchinari) è stato caratterizzato da una crescita media annua del +6,7%, cioè pari a quella del solo comparto ACT. Il dato però più interessante risulta il fatto che tra il 2022 e il 2023, la variazione percentuale dell’export dei prodotti ACT è stata più alta rispetto alla variazione percentuale per le restanti categorie di prodotto. Nel dettaglio, l’export italiano, macchinari esclusi, è cresciuto nell’area ALC solamente del 2,8% tra il 2022 e il 2023. Al contempo, l’export di beni ACT ha fatto registrare un incremento del +12,7%. Questo dato potrebbe rivelare una transizione delle economie latino-caraibiche da importatori di beni di consumo verso un assetto economico più stabile ed incentrato sull’internalizzazione di processi produttivi chiave per il loro sviluppo economico e sociale.
L’export ACT nell’area ALC può contare su quattro pilastri. Il Grafico 4.2 mostra la segmentazione per comparto dell’export ACT italiano nell’area economica dell’ALC. Nel 2018, le macchine per confezionamento ed imballaggio, le macchine e stampi per materie plastiche e gomma, i sistemi e componenti meccatronici per la trasmissione potenza e le macchine utensili, robot e automazione Catturavano circa i due terzi (circa il 65%) dell’export totale nell’area. La quota di questi comparti aumenta nel 2023, superando i due terzi dell’export totale; da soli rappresentano circa il 69% del totale dell’export ACT italiano nell’area ALC. Particolarmente interessante risulta l’aumento di 3 p.p., dal 9% al 12%, della quota delle macchine utensili, robot e automazione. Questa risulta infatti la variazione positiva più ampia fatta registrare a livello di comparto nell’area ALC. D’altra parte, il comparto più rappresentato, quello delle macchine per confezionamento e imballaggio, cede, nel quinquennio 2018-2023, poco più di 4 p.p. passando dal 28,4% al 24,2%.

Il Messico primo per domanda di beni ACT nell’area. Circa il 90% dell’export mondiale di beni ACT nell’area latino-caraibica è catturato da sei economie: Messico, Brasile, Argentina, Cile, Colombia e Perù (Grafico 4.3). Tra queste, il Messico si posiziona al primo posto come principale mercato di sbocco per i beni ACT nell’area ALC (Grafico 4.3). Infatti, nel 2018, così come nel 2022, l’economia centro-americana risulta il principale importatore di macchinari dell’area a livello mondiale. Questo primato è stato, nel quinquennio considerato, lievemente impattato dalla crescita delle altre economie emergenti della regione: Brasile in primis.
In particolare, il Messico ha visto ridursi di circa 4 p.p. la sua quota, da 48,9% a 45,1%. Questa leggera flessione si è verificata a seguito dello sviluppo delle altre principali economie. Tra queste, il Brasile ha visto aumentare la propria quota di poco più di 3 p.p. tra il 2018 e il 2022 (dal 21,9% al 25,2%). Allo stesso modo, seppur ad una scala inferiore, anche Argentina, Cile, Colombia e Perù hanno incrementato il proprio import di prodotti ACT tra il 2018 e il 2022. Questa dinamica evidenzia come tutte le maggiori economie dell’area stiano puntando verso uno sviluppo delle proprie economie, da meri mercati di sbocco per beni di consumo esteri ad hub produttivi in grado di soddisfare principalmente i bisogni interni ma anche di incrementare il proprio peso sui mercati internazionali in termini di export.

Il Messico risulta anche il principale importatore nell’area ALC per i beni ACT Made in Italy. Volgendo ora lo sguardo nello specifico all’export italiano nell’area ALC, si riscontra la stessa dinamica e segmentazione vista in precedenza (Grafico 4.4). In particolare, la quasi totalità dell’export italiano ACT nell’area ALC è assorbito, al 2018 così come al 2023, da sei paesi: Messico, Brasile, Argentina, Cile, Colombia e Perù. Nel dettaglio, nel 2018 questi paesi assorbivano l’88% dell’intero export italiano di beni ACT nell’area ALC. Questa quota è sensibilmente aumentata nel 2023, dove l’88,4% dell’export italiano di beni ACT è stato assorbito dalle stesse sei economie. Questo aumento, seppur lieve, rispecchia l’aumentata permeabilità di questi paesi all’export Made in Italy. Tra questi sei paesi, il principale partner commerciale risulta di gran lunga essere il Messico, con una quota di export detenuta del 37,6% nel 2018 e cresciuta nel 2023 al 40,2% (Grafico 4.4).

La segmentazione riportata nel Grafico 4.4 si ritrova anche a un livello più profondo se si guarda alle quote detenute dai singoli paesi per ciascun comparto. Osservando il Grafico 4.5 salta immediatamente all’occhio come in ciascun comparto, le sei principali economie catturino una quota rilevante dell’export italiano di beni strumentali in tutti i settori considerati.
In alcuni settori, come per esempio quello delle macchine e materiali per fonderie, questi paesi rappresentano quasi la totalità dell’export italiano nell’area (circa il 98,1% nel 2018 e circa il 97,5% nel 2023). Altri settori, come per esempio quello delle macchine per l’industria tessile, risultano invece meno concentrati, seppur caratterizzati da una quota detenuta dalle sei maggiori economie dell’area superiore al 70%.


Più nel dettaglio, osservando il Grafico 4.5 si evince come sia nel 2018 che nel 2023 Messico e Brasile risultino i principali mercati di sbocco per i beni strumentali in ciascun comparto. La struttura delle quote dei singoli settori riflette i cambiamenti evidenziati in precedenza (Grafico 4.3) con Messico e Brasile che si spartiscono il primato di principale importatore (per quote di export detenute) nei vari comparti. Nel 2018, spiccano per polarizzazione il comparto delle macchine e attrezzature per la lavorazione delle pietre naturali, le macchine e materiali per fonderie e i sistemi e componenti meccatronici per la trasmissione di potenza. Il Brasile domina il primo e il terzo, mentre il Messico risulta il principale partner commerciale per il secondo. La polarizzazione del comparto delle macchine e attrezzature per la lavorazione delle pietre naturali viene meno nel 2023, dove le quote di Messico e Brasile risultano pressoché identiche. Il dominio del Messico e del Brasile, in termini di assorbimento di beni strumentali Made in Italy, rispecchia l’importanza di queste due economie come principali mercati dell’area ALC. Infatti, il terzo mercato di sbocco, l’Argentina, risulta, in aggregato, notevolmente indietro in termini di quote dell’export assorbite. Un’eccezione è il comparto delle macchine e attrezzature per ceramica, dove l’Argentina, con una quota del 26,6%, risulta il secondo mercato di sbocco (dietro al Messico) per l’export italiano del settore.
L’area ALC piuttosto dinamica per quanto riguarda l’import di beni strumentali. Per valutare la dinamicità relativa dell’area ALC ci serviamo di tre informazioni che, se lette nel loro insieme, possono ricondurre a una misura implicita di dinamicità. In primo luogo, consideriamo le quote di ogni singolo paese appartenente all’area dell’America Latina e ALC al 2018 e al 2023. Il secondo elemento considerato è il tasso di crescita medio annuo (CAGR) dell’import ACT italiano tra il 2018 e il 2023 per ogni singolo paese. Infine, prendiamo in considerazione il tasso di crescita medio annuo export ACT totale, tra il 2018 e il 2023, nell’area ALC.
Le quote forniscono un quadro sui principali mercati di sbocco per l’export italiano, mentre la comparazione dei tassi di crescita media annui a livello paese con quello totale dell’export ACT aiuta a evidenziare quali paesi si sono rivelati ricettivi principalmente ai macchinari Made in Italy. Il Grafico 4.6 fornisce un colpo d’occhio sulla dinamicità dell’area ALC, scomposta per paesi, inquadrata in termini relativi ovvero comparando i tassi medi di crescita dell’export ACT nei singoli paesi con il tasso di crescita medio nel quinquennio 2018-2023 dell’export totale ACT nell’area ALC. Il primo dato interessante riguarda il fatto che nella maggioranza dei paesi considerati, il tasso di crescita medio tra il 2018 e il 2023 è stato generalmente positivo; solo cinque paesi hanno fatto registrare un tasso di crescita negativo: Cuba, Uruguay, Paraguay, Trinidad e Tobago e Haiti. Questa crescita generalizzata dell’export ACT italiano nei principali paesi nell’area dimostra come essa risulti un mercato particolarmente permeabile.
Nel dettaglio, tra le prime sei maggiori destinazioni per i beni ACT italiani, spicca il Perù con un tasso di crescita fortemente positivo, +14,8%. D’altro canto, i due principali partner commerciali, Brasile e Messico, fanno registrare tassi di crescita lievemente superiori al tasso di crescita totale: rispettivamente il +6,7% e +8,1%. Interessante anche la dinamica colombiana, che, seppur con una quota al 2023 del 4,9%, fa registrare un tasso di crescita medio annuo del +7,0%. Restano indietro Argentina (+2,0%) e Cile (+0,3%). Questi dati evidenziano come le economie latino-caraibiche risultino, in larga maggioranza, mercati emergenti con un forte potenziale sfruttabile. Il Grafico 4.6 evidenzia anche come paesi detentori di quote dell’export italiano di esigue dimensioni – come Venezuela e Nicaragua – nel quinquennio 2018-2023 abbiano aumentato il proprio import in maniera notevole. Questo si riflette nei tassi di crescita esorbitanti: +21,6% il primo e +33,4% il secondo. Questo dato non va però direttamente tradotto in termini di maggiore appetibilità di queste economie per quanto riguarda le possibilità di espansione dell’export.

Concorrenti: USA principale esportatore di macchinari verso l’area. È utile mettere in prospettiva l’export italiano di prodotti ACT nell’area ALC con le quote detenute dai principali competitor nell’area. Non sorprende che gli Stati Uniti (Grafico 4.7) dominino, in termini di quote dell’export, il mercato dei beni ACT. Chiaramente, l’influenza statunitense sulla regione risulta ad oggi molto forte, anche alla luce dei contratti commerciali stipulati con il principale mercato di sbocco dei beni strumentali nella regione, ovvero il Messico, e il processo di nearshoring instauratosi a causa della guerra dei dazi tra Stati Uniti e Cina. La vicinanza geografica e la storica influenza esercitata dagli Stati Uniti nella regione giustificano il suo primato come principale esportatore di beni strumentali, con una quota nel 2022 del 31,4%.
Si consolida il ruolo della Cina nell’area. La Cina ha visto crescere notevolmente, quasi 10 p.p. dal 13,4% al 22,7%, il peso delle proprie quote di export di beni ACT tra il 2018 e il 2022. Nonostante l’enorme crescita, il gigante asiatico rimane ancora indietro rispetto agli Stati Uniti. L’aumento della presenza cinese nell’area ALC, per quanto riguarda i beni strumentali, è un chiaro segnale di come l’economia del Dragone abbia notevolmente accresciuto la propria capacità produttiva ben al di là del semplice comparto manifatturiero relativo ai beni finali di consumo. Questo aumento è anche la contromossa del gigante asiatico per contrastare la riduzione del proprio export negli Stati Uniti.
Infatti, la postura protezionista assunta dagli USA – principalmente tramite l’imposizione di pesanti dazi sui prodotti importati dalla Cina – ha indotto la Cina a cercare vie secondarie per l’esportazione dei propri prodotti all’interno del mercato americano. In questo contesto, i mercati centro-americani hanno acquisito il ruolo di mercati di sbocco intermedi per i prodotti cinesi destinati all’enorme mercato interno degli Stati Uniti. L’ascesa cinese ha evidentemente influenzato negativamente i principali attori nella regione, compresi gli USA. In particolare, tutti i principali esportatori di beni strumentali nell’area ALC hanno visto ridursi la propria quota di mercato (Grafico 4.7).

L’export italiano di macchinari verso l’area tiene più di quello tedesco e giapponese. L’Italia non è esclusa da questa perdita di terreno generalizzata. Infatti, l’export italiano di beni ACT ha visto la sua quota ridursi tra il 2018 e il 2022, dall’8,5% al 7,9%, ossia meno di 1 punto percentuale. La perdita di terreno dell’export italiano risulta nettamente la più contenuta, se comparata con la flessione fatta registrare dai principali competitors. Infatti, la Germania nello stesso periodo ha visto ridursi la propria quota dal 13,2% al 9,9%, ovvero poco più di 3 p.p. Allo stesso modo, il Giappone ha visto ridursi la propria quota di mercato di 2 p.p., dal 6,9% al 4,9%. Nonostante questa perdita di terreno, l’Italia si posiziona comunque al quarto posto come maggior esportatore di beni ATC nell’area ALC, dietro a colossi come Stati Uniti, Cina e Germania. Questo dato è emblematico della capacità di resilienza e penetrazione dell’export italiano ACT nell’area.
L’export italiano detiene quote rilevanti nei settori delle macchine per calzature e pelle, macchine imballaggio e macchine per pietre La Tab 1. presenta la scomposizione delle quote presentate nel Grafico 4.7 per settori. Questa scomposizione permette di individuare i settori nei quali l’export italiano si mostra particolarmente forte. Nel dettaglio, la Tab 1. mostra, in retrospettiva, come nel 2018 l’Italia fosse il leader per quanto riguarda le macchine per calzature e pelle (quota del 57,8%), le macchine per imballaggio (26,7%) e le macchine per pietre (29,2%). Il quadro non cambia nel 2022: l’Italia mantiene il primato come principale esportatore di macchinari per calzature e pelle in nell’area ALC con una quota, seppur lievemente diminuita, comunque rilevante (42%). La leadership è mantenuta, seppure con una quota lievemente minore, anche per quanto riguarda le macchine per imballaggio (23,2%). Nel settore delle macchine per pietre, il primato italiano è venuto meno a causa dell’avanzata cinese. Rimane comunque rilevante la quota detenuta dell’Italia in questo settore (26,7%).
Oltre a rimanere il primo esportatore nei settori sopra citati, l’Italia ha incrementato le proprie quote nei settori delle macchine per fonderia, macchine per la ceramica, macchine per grafica e cartotecnica e macchine per trasmissione potenza. Tra queste, un’eccellenza risulta il settore delle macchine per ceramica. Infatti, con un aumento di quasi 14 p.p. tra il 2018 e il 2022, l’Italia risulta il primo esportatore dell’area ALC.

Il Messico è l’economia più aperta tra le principali dell’area: l’interscambio commerciale rappresenta infatti l’88% del PIL. La principale leva è sicuramente la vicinanza con il mercato statunitense, ma non è l’unica. La manifattura messicana è, infatti, particolarmente diversificata, soprattutto se paragonata a quella di molti peer dell’area (Grafico 4.8). Il Paese, pur essendo ancora formalmente etichettato come emergente, è di fatto e dal punto di vista della diversificazione produttiva, un’economia avanzata, dove la forza lavoro è ben istruita, qualificata e disponibile a costi relativamente competitivi. Le svariate politiche attuate dal governo per promuovere lo sviluppo industriale multisettoriale e attrarre investimenti nei settori high-tech hanno creato un ambiente imprenditoriale favorevole, lasciando alle spalle il vecchio modello delle “maquiladora” – grandi fabbriche, per lo più di proprietà straniera, impegnate nell’assemblaggio, ad alta intensità di manodopera, di beni intermedi e finali per l’esportazione – affermandosi come attore globale nella produzione di beni complessi e ad alto valore aggiunto.
L’industria automobilistica rimane una pietra miliare della produzione messicana, ma non è più l’unico settore su cui punta il Paese. Negli ultimi anni, in particolare, il Messico è emerso come un hub per la produzione ad alta tecnologia: settori come l’aerospazio, i dispositivi medici e l’elettronica hanno visto una crescita significativa, contribuendo all’espansione della base manifatturiera del Paese e ad attrarre investimenti esteri.
I rapporti commerciali tra Italia e Messico sono significativi: terza destinazione dell’export italiano verso le Americhe dopo Stati Uniti e Canada e prima in America Latina, nonostante il Brasile sia un mercato molto più grande in termini di popolazione e dimensione dell’economia.

La performance delle esportazioni di beni Made in Italy verso il Messico è stata particolarmente positiva nel post-pandemia, soprattutto se raffrontata a quella verso l’America Latina e, più in generale, verso il mondo (Grafico 4.9). Lo scorso anno le vendite Made in Italy oltreconfine hanno raggiunto un valore pari a 6,2 miliardi di euro, crescendo dell’11,3% a fronte di una sostanziale stabilità dell’export italiano complessivo. A trainare tale performance è la forte crescita della meccanica strumentale (+18,5%), primo settore di sbocco verso il Paese.
La dinamica positiva a doppia cifra si sta confermando anche quest’anno sia per l’export di beni sia, in particolare, per i macchinari. Le previsioni SACE, che presidia il paese da ormai dieci anni con un ufficio a Città del Messico, vedono nuovamente una crescita marcata e al di sopra del totale verso il Messico nel 2025 (+7% circa sia per il totale beni che per la meccanica strumentale) e un ulteriore +4%, in media, nel biennio successivo.
La complessità produttiva messicana garantisce una domanda diversificata di macchinari – anche dall’estero – e ha spinto le vendite dei beni ACT italiani (Figura 4.9). In particolare, negli ultimi cinque anni l’export di ACT verso il Messico è cresciuto a un tasso medio annuo (CAGR) del 15,8%, contro un +3,9% verso il mondo e +7,8% verso il resto dell’area latino-americana, aumentando di più di 1 punto percentuale il peso del Paese come destinazione di questi beni.
I tre quinti del valore dei macchinari ACT italiani che varcano il confine messicano sono rappresentati da macchine per imballaggio, per gomma e plastica e utensili (Grafico 4.10). Rispetto all’ACT italiano venduto in tutto il mondo, tali comparti sono molto più rilevanti, mentre hanno un peso inferiore le macchine per trasmissione e potenza – primo segmento per export ACT globale – e, in misura minore, le macchine per la lavorazione del legno. Nell’ultimo quinquennio i principali comparti hanno riportato crescite medie a doppia cifra, superando ampiamente i valori pre-pandemia.
L’incidenza dei beni ACT sulla meccanica strumentale esportata verso il Messico è vicina al 45%, ben al di sopra di quella registrata verso il mondo (circa 30%), a riprova del fatto che il tessuto imprenditoriale messicano si sta evolvendo verso lavorazioni a elevato contenuto tecnologico e che richiedono quindi macchinari ad alta intensità di automazione, creatività e tecnologia.


Con una quota di oltre il 6%, l’Italia si colloca come secondo venditore europeo di beni ACT in Messico e quarto al mondo (Tabella 4.2). A livello di totale ACT, seppur ben posizionate, le imprese italiane sono lontane dal market share di quelle statunitensi – che detengono il 41% del mercato – e da quelle cinesi. Vi sono però comparti dove l’Italia eccelle. Si tratta, ad esempio, dei macchinari per il packaging, in cui il Made in Italy soddisfa più di un quarto della domanda di import messicana, al pari degli Stati Uniti. Sebbene siano comparti dalle dimensioni più contenute, la quota italiana di macchinari e attrezzature per la ceramica supera di oltre 15 p.p. quella americana ed è addirittura doppia nel caso delle macchine per calzature e pelle.
In prospettiva, il mercato messicano continuerà a rappresentare uno sbocco ricco di opportunità per le macchine per il confezionamento e l’imballaggio Made in Italy. Tali macchinari sono infatti ampiamente utilizzati nell’industria della trasformazione alimentare ma anche in quella farmaceutica, che nel Paese stanno registrando andamenti interessanti.
L’industria della trasformazione alimentare messicana è, infatti, particolarmente sviluppata ed è la terza più grande in America, dopo Stati Uniti e Brasile, con numerose società internazionali che investono nel Paese riconoscendone le potenzialità, ma anche una forte presenza di imprese domestiche. Si stima che nel solo segmento di dolciumi e snack siano attivi circa 1.500 player. Anche il settore delle bevande ha un peso importante nell’economia, considerato che il Messico riporta tra i maggiori consumi pro-capite di bevande analcoliche a livello globale e il Paese ospita un gran numero di produttori, da piccoli birrifici locali a gruppi multinazionali di bevande analcoliche tra i più grandi al mondo. Le tendenze demografiche, che vedono un aumento del numero di famiglie composte da una sola persona e di donne che lavorano fuori casa, con un conseguente aumento della domanda di cibi pronti e alimenti surgelati confezionati, potranno generare maggiore domanda di macchinari per il packaging nei prossimi anni. Inoltre, la crescente attenzione alla sostenibilità porterà i player del settore a ricercare soluzioni di packaging green, spingendo ancora una volta la domanda di macchinari innovativi.

Anche l’industria farmaceutica domestica, seppur di dimensioni più contenute, mostra buone prospettive di crescita. Alcune iniziative promosse dal governo per migliorare la produzione locale di farmaci daranno impulso al settore, favorendo partnership internazionali e formazione di know-how.
Il decreto emesso dal Ministero delle Finanze e del Credito Pubblico messicano nell’ottobre 2023, ad esempio, ha aggiunto ulteriori incentivi a promozione del nearshoring, garantendo agevolazioni fiscali a settori chiave dell’industria, tra cui la farmaceutica. Nello stesso mese, COFEPRIS – la commissione federale per la protezione dai rischi sanitari – ha avviato, insieme ai rappresentanti dell’industria farmaceutica, un piano di lavoro quadriennale per promuovere lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di biotecnologie nel Paese.
Non da ultimo, recentemente Messico e Brasile hanno formato un’alleanza strategica per dare impulso ai settori farmaceutici domestici, guidando l’innovazione e le capacità produttive locali. Tali sviluppi potranno avere risvolti positivi anche sulla domanda di macchinari per il packaging specializzati per l’industria farmaceutica.
Prospettive interessanti si riscontrano anche per le macchine per l’industria tessile e, più in generale, quelle legate all’industria della moda. Il Messico vanta, infatti, una lunga tradizione nella produzione tessile ed è un mercato attraente per gli investitori internazionali attivi nel settore grazie a una manodopera qualificata e dal costo competitivo, così come alla prossimità a Stati Uniti e Canada, mercati di sbocco finali ad alto potenziale.
La regola di origine “yarn-forward” prevista nell’USMCA ha inoltre reso ancor più competitiva l’industria messicana: secondo tale disposizione, affinché un capo di abbigliamento o un tessuto possa beneficiare del trattamento esente da dazi previsto nell’accordo, ogni componente a partire dal filato deve essere realizzato all’interno dell’area di libero scambio. Alla luce di questo requisito, il Messico è diventato un’opzione sempre più attraente rispetto all’import di semilavorati da Paesi terzi, dando ulteriore impulso all’industria locale.
I tessuti tecnici per automotive, industria aerospaziale e dei dispositivi medici sono inoltre nicchie specializzate in rapido sviluppo, considerando l’evoluzione di questi settori nel Paese. Più in generale, i produttori tessili messicani stanno abbracciando i progressi tecnologici per migliorare l’efficienza e ridurre l’impatto ambientale. In questo contesto, macchinari altamente automatizzati – come quelli ACT – stanno diventando componenti integranti dell’evoluzione del settore.
Non da ultimo, le macchine per plastica e gomma italiane continueranno a trovare nel Messico una destinazione ad alto potenziale. L’industria della gomma e plastica locale è cresciuta sopra il 5% in media tra il 2018 e il 2022 e fornisce importanti settori dell’economia messicana – tra cui costruzioni, automotive, packaging, ma anche tessile, dispositivi medici e agricoltura – nonché gli altri mercati parte dell’USMCA. Oltre agli sviluppi nei settori di sbocco, la gomma e plastica – e i macchinari per la lavorazione – sarà spinta anche dalla ricerca di soluzioni sostenibili, quali la produzione di bioplastiche e il riciclaggio. Le quote di mercato sono anche riflesso dei numerosi accordi commerciali di cui il Paese beneficia, tra cui il più conosciuto USMCA fino a quello con l’Unione europea, che genera potenzialità anche per l’export italiano. La stretta relazione con gli Stati Uniti è stata e tutt’ora è un fattore abilitante per lo sviluppo economico e sociale del Messico, sia dal punto di vista della domanda che dell’offerta. La vicinanza geografica agevola il flusso di beni, servizi, persone e conoscenze, così come gli investimenti americani in territorio messicano. In tal senso, l’implementazione dell’accordo commerciale NAFTA nel 1994 e la sua evoluzione nell’USMCA hanno giocato un ruolo cruciale, rendendo il Messico una destinazione attraente per le aziende manifatturiere statunitensi e canadesi; così come il programma IMMEX (Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación) ha incentivato le aziende a stabilire operazioni di produzione in Messico, offrendo vantaggi fiscali e doganali.
Allo stesso tempo, la pur relativa vicinanza geografica ha reso il Paese una destinazione di opportunità per l’export cinese. I beni del Dragone – soprattutto elettronica, veicoli e macchinari – che hanno varcato i confini messicani sono aumentati notevolmente, rappresentando oggi un quinto di tutto l’import del Paese. Il viaggio inverso, seppur cresciuto, si è mantenuto su valori contenuti, causando un forte deterioramento del deficit commerciale del Messico con la Cina. Se da un lato le importazioni a basso costo dalla Cina di svariati prodotti hanno contribuito a ridurre l’inflazione dei beni, dall’altro la forte crescita delle esportazioni cinesi rappresenta una “minaccia” per lo sviluppo dei settori manifatturieri nazionali. E dunque non sorprende – in virtù anche di un allineamento geopolitico con gli Stati Uniti e dell’importanza del manifatturiero nell’economia messicana – che il Paese possa adottare misure restrittive nei confronti di imprese, prodotti e investimenti cinesi. Inoltre, la prossima amministrazione USA, quando nel 2026 sarà chiamata (insieme ai governi messicano e canadese) a rivedere l’accordo USMCA, potrebbe spingere verso regole di origine più severe e/o requisiti di contenuto di manodopera.
Unione europea e Messico hanno siglato un primo accordo di partenariato nel 1997, la cui applicazione per la parte commerciale è avvenuta nel 2000. Nel 2018 è stata la volta di un nuovo accordo globale di associazione con una pressoché contestuale intesa sulla parte commerciale e nel 2020 sul resto (tra cui norme innovative sullo sviluppo sostenibile, sulla protezione degli investimenti, sulla tutela dei diritti umani, sulla cooperazione politica e sullo sviluppo, fino alla lotta alla corruzione), garantendo l’esenzione di dazi per gli scambi di merci tra le parti.
Anche in ottica prospettica, ulteriori opportunità potranno arrivare dall’implementazione del piano di sviluppo economico promosso dalla presidenza Sheinbaum, che pone al centro 5 settori strategici – semiconduttori, elettronica, mobilità elettrica, dispositivi medicali e agroalimentare – e prevede la creazione di 10 nuovi “corridoi” industriali in tutto il Paese, progettati per sfruttare i punti di forza delle diverse regioni e promuovere la crescita economica. Dalla manifattura specializzata, all’agritech, fino alle industrie elettriche ed elettroniche, in ognuno di questi corridoi sono evidenti le numerose opportunità per i beni ACT (Figura 4.1).
